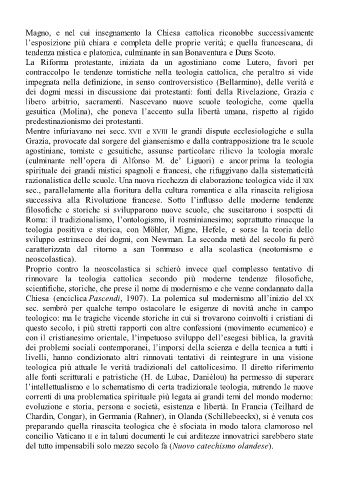Page 830 - Dizionario di Filosofia
P. 830
Magno, e nel cui insegnamento la Chiesa cattolica riconobbe successivamente
l’esposizione più chiara e completa delle proprie verità; e quella francescana, di
tendenza mistica e platonica, culminante in san Bonaventura e Duns Scoto.
La Riforma protestante, iniziata da un agostiniano come Lutero, favorì per
contraccolpo le tendenze tomistiche nella teologia cattolica, che peraltro si vide
impegnata nella definizione, in senso controversistico (Bellarmino), delle verità e
dei dogmi messi in discussione dai protestanti: fonti della Rivelazione, Grazia e
libero arbitrio, sacramenti. Nascevano nuove scuole teologiche, come quella
gesuitica (Molina), che poneva l’accento sulla libertà umana, rispetto al rigido
predestinazionismo dei protestanti.
Mentre infuriavano nei secc. XVII e XVIII le grandi dispute ecclesiologiche e sulla
Grazia, provocate dal sorgere del giansenismo e dalla contrapposizione tra le scuole
agostiniane, tomiste e gesuitiche, assunse particolare rilievo la teologia morale
(culminante nell’opera di Alfonso M. de’ Liguori) e ancor prima la teologia
spirituale dei grandi mistici spagnoli e francesi, che rifuggivano dalla sistematicità
razionalistica delle scuole. Una nuova ricchezza di elaborazione teologica vide il XIX
sec., parallelamente alla fioritura della cultura romantica e alla rinascita religiosa
successiva alla Rivoluzione francese. Sotto l’influsso delle moderne tendenze
filosofiche e storiche si svilupparono nuove scuole, che suscitarono i sospetti di
Roma: il tradizionalismo, l’ontologismo, il rosminianesimo; soprattutto rinacque la
teologia positiva e storica, con Möhler, Migne, Hefele, e sorse la teoria dello
sviluppo estrinseco dei dogmi, con Newman. La seconda metà del secolo fu però
caratterizzata dal ritorno a san Tommaso e alla scolastica (neotomismo e
neoscolastica).
Proprio contro la neoscolastica si schierò invece quel complesso tentativo di
rinnovare la teologia cattolica secondo più moderne tendenze filosofiche,
scientifiche, storiche, che prese il nome di modernismo e che venne condannato dalla
Chiesa (enciclica Pascendi, 1907). La polemica sul modernismo all’inizio del XX
sec. sembrò per qualche tempo ostacolare le esigenze di novità anche in campo
teologico: ma le tragiche vicende storiche in cui si trovarono coinvolti i cristiani di
questo secolo, i più stretti rapporti con altre confessioni (movimento ecumenico) e
con il cristianesimo orientale, l’impetuoso sviluppo dell’esegesi biblica, la gravità
dei problemi sociali contemporanei, l’imporsi della scienza e della tecnica a tutti i
livelli, hanno condizionato altri rinnovati tentativi di reintegrare in una visione
teologica più attuale le verità tradizionali del cattolicesimo. Il diretto riferimento
alle fonti scritturali e patristiche (H. de Lubac, Daniélou) ha permesso di superare
l’intellettualismo e lo schematismo di certa tradizionale teologia, nutrendo le nuove
correnti di una problematica spirituale più legata ai grandi temi del mondo moderno:
evoluzione e storia, persona e società, esistenza e libertà. In Francia (Teilhard de
Chardin, Congar), in Germania (Rahner), in Olanda (Schillebeeckx), si è venuta così
preparando quella rinascita teologica che è sfociata in modo talora clamoroso nel
concilio Vaticano II e in taluni documenti le cui arditezze innovatrici sarebbero state
del tutto impensabili solo mezzo secolo fa (Nuovo catechismo olandese).