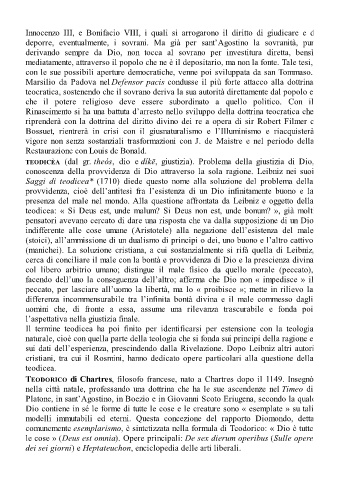Page 827 - Dizionario di Filosofia
P. 827
Innocenzo III, e Bonifacio VIII, i quali si arrogarono il diritto di giudicare e di
deporre, eventualmente, i sovrani. Ma già per sant’Agostino la sovranità, pur
derivando sempre da Dio, non tocca al sovrano per investitura diretta, bensì
mediatamente, attraverso il popolo che ne è il depositario, ma non la fonte. Tale tesi,
con le sue possibili aperture democratiche, venne poi sviluppata da san Tommaso.
Marsilio da Padova nel Defensor pacis condusse il più forte attacco alla dottrina
teocratica, sostenendo che il sovrano deriva la sua autorità direttamente dal popolo e
che il potere religioso deve essere subordinato a quello politico. Con il
Rinascimento si ha una battuta d’arresto nello sviluppo della dottrina teocratica che
riprenderà con la dottrina del diritto divino dei re a opera di sir Robert Filmer e
Bossuet, rientrerà in crisi con il giusnaturalismo e l’Illuminismo e riacquisterà
vigore non senza sostanziali trasformazioni con J. de Maistre e nel periodo della
Restaurazione con Louis de Bonald.
TEODICÈA (dal gr. theós, dio e díkē, giustizia). Problema della giustizia di Dio,
conoscenza della provvidenza di Dio attraverso la sola ragione. Leibniz nei suoi
Saggi di teodicea* (1710) diede questo nome alla soluzione del problema della
provvidenza, cioè dell’antitesi fra l’esistenza di un Dio infinitamente buono e la
presenza del male nel mondo. Alla questione affrontata da Leibniz e oggetto della
teodicea: « Si Deus est, unde malum? Si Deus non est, unde bonum? », già molti
pensatori avevano cercato di dare una risposta che va dalla supposizione di un Dio
indifferente alle cose umane (Aristotele) alla negazione dell’esistenza del male
(stoici), all’ammissione di un dualismo di principi o dei, uno buono e l’altro cattivo
(manichei). La soluzione cristiana, a cui sostanzialmente si rifà quella di Leibniz,
cerca di conciliare il male con la bontà e provvidenza di Dio e la prescienza divina
col libero arbitrio umano; distingue il male fisico da quello morale (peccato),
facendo dell’uno la conseguenza dell’altro; afferma che Dio non « impedisce » il
peccato, per lasciare all’uomo la libertà, ma lo « proibisce »; mette in rilievo la
differenza incommensurabile tra l’infinita bontà divina e il male commesso dagli
uomini che, di fronte a essa, assume una rilevanza trascurabile e fonda poi
l’aspettativa nella giustizia finale.
Il termine teodicea ha poi finito per identificarsi per estensione con la teologia
naturale, cioè con quella parte della teologia che si fonda sui principi della ragione e
sui dati dell’esperienza, prescindendo dalla Rivelazione. Dopo Leibniz altri autori
cristiani, tra cui il Rosmini, hanno dedicato opere particolari alla questione della
teodicea.
TEODORICO di Chartres, filosofo francese, nato a Chartres dopo il 1149. Insegnò
nella città natale, professando una dottrina che ha le sue ascendenze nel Timeo di
Platone, in sant’Agostino, in Boezio e in Giovanni Scoto Eriugena, secondo la quale
Dio contiene in sé le forme di tutte le cose e le creature sono « esemplate » su tali
modelli immutabili ed eterni. Questa concezione del rapporto Diomondo, detta
comunemente esemplarismo, è sintetizzata nella formula di Teodorico: « Dio è tutte
le cose » (Deus est omnia). Opere principali: De sex dierum operibus (Sulle opere
dei sei giorni) e Heptateuchon, enciclopedia delle arti liberali.