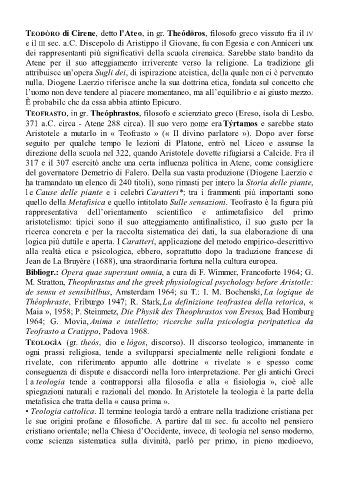Page 828 - Dizionario di Filosofia
P. 828
TEODÒRO di Cirene, detto l’Ateo, in gr. Theódōros, filosofo greco vissuto fra il IV
e il III sec. a.C. Discepolo di Aristippo il Giovane, fu con Egesia e con Anniceri uno
dei rappresentanti più significativi della scuola cirenaica. Sarebbe stato bandito da
Atene per il suo atteggiamento irriverente verso la religione. La tradizione gli
attribuisce un’opera Sugli dei, di ispirazione ateistica, della quale non ci è pervenuto
nulla. Diogene Laerzio riferisce anche la sua dottrina etica, fondata sul concetto che
l’uomo non deve tendere al piacere momentaneo, ma all’equilibrio e ai giusto mezzo.
È probabile che da essa abbia attinto Epicuro.
TEOFRASTO, in gr. Theóphrastos, filosofo e scienziato greco (Ereso, isola di Lesbo,
371 a.C. circa - Atene 288 circa). Il suo vero nome era Týrtamos e sarebbe stato
Aristotele a mutarlo in « Teofrasto » (« Il divino parlatore »). Dopo aver forse
seguito per qualche tempo le lezioni di Platone, entrò nel Liceo e assunse la
direzione della scuola nel 322, quando Aristotele dovette rifugiarsi a Calcide. Fra il
317 e il 307 esercitò anche una certa influenza politica in Atene, come consigliere
del governatore Demetrio di Falero. Della sua vasta produzione (Diogene Laerzio ci
ha tramandato un elenco di 240 titoli), sono rimasti per intero la Storia delle piante,
l e Cause delle piante e i celebri Caratteri*; tra i frammenti più importanti sono
quello della Metafisica e quello intitolato Sulle sensazioni. Teofrasto è la figura più
rappresentativa dell’orientamento scientifico e antimetafisico del primo
aristotelismo: tipici sono il suo atteggiamento antifinalistico, il suo gusto per la
ricerca concreta e per la raccolta sistematica dei dati, la sua elaborazione di una
logica più duttile e aperta. I Caratteri, applicazione del metodo empirico-descrittivo
alla realtà etica e psicologica, ebbero, soprattutto dopo la traduzione francese di
Jean de La Bruyère (1688), una straordinaria fortuna nella cultura europea.
Bibliogr.: Opera quae supersunt omnia, a cura di F. Wimmer, Francoforte 1964; G.
M. Stratton, Theophrastus and the greek physiological psychology before Aristotle:
de sensu et sensibitlbus, Amsterdam 1964; su T.: I. M. Bochenski, La logique de
Théophraste, Friburgo 1947; R. Stark, La definizione teofrastea della retorica, «
Maia », 1958; P. Steinmetz, Die Physik des Theophrastos von Eresos, Bad Homburg
1964; G. Movia, Anima e intelletto; ricerche sulla psicologia peripatetica da
Teofrasto a Cratippo, Padova 1968.
TEOLOGÌA (gr. theós, dio e lògos, discorso). Il discorso teologico, immanente in
ogni prassi religiosa, tende a svilupparsi specialmente nelle religioni fondate e
rivelate, con riferimento appunto alle dottrine « rivelate » e spesso come
conseguenza di dispute e disaccordi nella loro interpretazione. Per gli antichi Greci
l a teologia tende a contrapporsi alla filosofia e alla « fisiologia », cioè alle
spiegazioni naturali e razionali del mondo. In Aristotele la teologia è la parte della
metafisica che tratta della « causa prima ».
• Teologia cattolica. Il termine teologia tardò a entrare nella tradizione cristiana per
le sue origini profane e filosofiche. A partire dal III sec. fu accolto nel pensiero
cristiano orientale; nella Chiesa d’Occidente, invece, di teologia nel senso moderno,
come scienza sistematica sulla divinità, parlò per primo, in pieno medioevo,