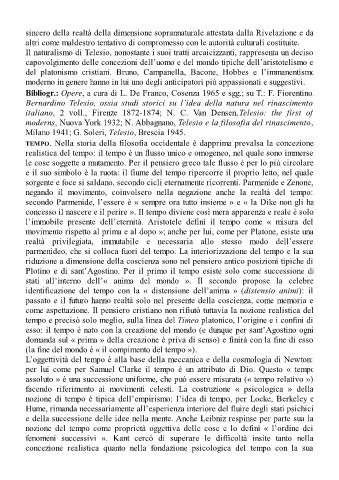Page 825 - Dizionario di Filosofia
P. 825
sincero della realtà della dimensione soprannaturale attestata dalla Rivelazione e da
altri come maldestro tentativo di compromesso con le autorità culturali costituite.
Il naturalismo di Telesio, nonostante i suoi tratti arcaicizzanti, rappresenta un deciso
capovolgimento delle concezioni dell’uomo e del mondo tipiche dell’aristotelismo e
del platonismo cristiani. Bruno, Campanella, Bacone, Hobbes e l’immanentismo
moderno in genere hanno in lui uno degli anticipatori più appassionati e suggestivi.
Bibliogr.: Opere, a cura di L. De Franco, Cosenza 1965 e sgg.; su T.: F. Fiorentino,
Bernardino Telesio, ossia studi storici su l’idea della natura nel rinascimento
italiano, 2 voll., Firenze 1872-1874; N. C. Van Densen, Telesio: the first of
moderns, Nuova York 1932; N. Abbagnano, Telesio e la filosofia del rinascimento,
Milano 1941; G. Soleri, Telesio, Brescia 1945.
TEMPO. Nella storia della filosofia occidentale è dapprima prevalsa la concezione
realistica del tempo: il tempo è un flusso unico e omogeneo, nel quale sono immerse
le cose soggette a mutamento. Per il pensiero greco tale flusso è per lo più circolare
e il suo simbolo è la ruota: il fiume del tempo ripercorre il proprio letto, nel quale
sorgente e foce si saldano, secondo cicli eternamente ricorrenti. Parmenide e Zenone,
negando il movimento, coinvolsero nella negazione anche la realtà del tempo:
secondo Parmenide, l’essere è « sempre ora tutto insieme » e « la Dike non gli ha
concesso il nascere e il perire ». Il tempo diviene così mera apparenza e reale è solo
l’immobile presente dell’eternità. Aristotele definì il tempo come « misura del
movimento rispetto al prima e al dopo »; anche per lui, come per Platone, esiste una
realtà privilegiata, immutabile e necessaria allo stesso modo dell’essere
parmenideo, che si colloca fuori del tempo. La interiorizzazione del tempo e la sua
riduzione a dimensione della coscienza sono nel pensiero antico posizioni tipiche di
Plotino e di sant’Agostino. Per il primo il tempo esiste solo come successione di
stati all’interno dell’« anima del mondo ». Il secondo propose la celebre
identificazione del tempo con la « distensione dell’anima » (distensio animi): il
passato e il futuro hanno realtà solo nel presente della coscienza, come memoria e
come aspettazione. Il pensiero cristiano non rifiutò tuttavia la nozione realistica del
tempo e precisò solo meglio, sulla linea del Timeo platonico, l’origine e i confini di
esso: il tempo è nato con la creazione del mondo (e dunque per sant’Agostino ogni
domanda sul « prima » della creazione è priva di senso) e finirà con la fine di esso
(la fine del mondo è « il compimento del tempo »).
L’oggettività del tempo è alla base della meccanica e della cosmologia di Newton:
per lui come per Samuel Clarke il tempo è un attributo di Dio. Questo « tempo
assoluto » è una successione uniforme, che può essere misurata (« tempo relativo »)
facendo riferimento ai movimenti celesti. La costruzione « psicologica » della
nozione di tempo è tipica dell’empirismo: l’idea di tempo, per Locke, Berkeley e
Hume, rimanda necessariamente all’esperienza interiore del fluire degli stati psichici
e della successione delle idee nella mente. Anche Leibniz respinse per parte sua la
nozione del tempo come proprietà oggettiva delle cose e lo definì « l’ordine dei
fenomeni successivi ». Kant cercò di superare le difficoltà insite tanto nella
concezione realistica quanto nella fondazione psicologica del tempo con la sua