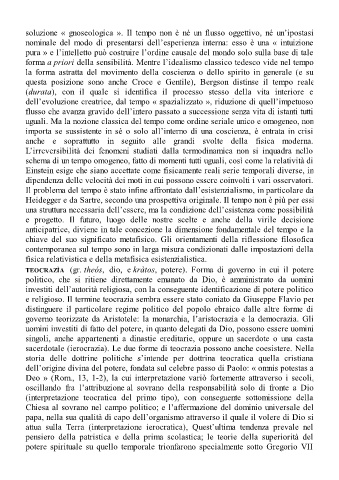Page 826 - Dizionario di Filosofia
P. 826
soluzione « gnoseologica ». Il tempo non è né un flusso oggettivo, né un’ipostasi
nominale del modo di presentarsi dell’esperienza interna: esso è una « intuizione
pura » e l’intelletto può costruire l’ordine causale del mondo solo sulla base di tale
forma a priori della sensibilità. Mentre l’idealismo classico tedesco vide nel tempo
la forma astratta del movimento della coscienza o dello spirito in generale (e su
questa posizione sono anche Croce e Gentile), Bergson distinse il tempo reale
(durata), con il quale si identifica il processo stesso della vita interiore e
dell’evoluzione creatrice, dal tempo « spazializzato », riduzione di quell’impetuoso
flusso che avanza gravido dell’intero passato a successione senza vita di istanti tutti
uguali. Ma la nozione classica del tempo come ordine seriale unico e omogeneo, non
importa se sussistente in sé o solo all’interno di una coscienza, è entrata in crisi
anche e soprattutto in seguito alle grandi svolte della fisica moderna.
L’irreversibilità dei fenomeni studiati dalla termodinamica non si inquadra nello
schema di un tempo omogeneo, fatto di momenti tutti uguali, così come la relatività di
Einstein esige che siano accettate come fisicamente reali serie temporali diverse, in
dipendenza delle velocità dei moti in cui possono essere coinvolti i vari osservatori.
Il problema del tempo è stato infine affrontato dall’esistenzialismo, in particolare da
Heidegger e da Sartre, secondo una prospettiva originale. Il tempo non è più per essi
una struttura necessaria dell’essere, ma la condizione dell’esistenza come possibilità
e progetto. Il futuro, luogo delle nostre scelte e anche della virile decisione
anticipatrice, diviene in tale concezione la dimensione fondamentale del tempo e la
chiave del suo significato metafisico. Gli orientamenti della riflessione filosofica
contemporanea sul tempo sono in larga misura condizionati dalle impostazioni della
fìsica relativistica e della metafisica esistenzialistica.
TEOCRAZÌA (gr. theós, dio, e kràtos, potere). Forma di governo in cui il potere
politico, che si ritiene direttamente emanato da Dio, è amministrato da uomini
investiti dell’autorità religiosa, con la conseguente identificazione di potere politico
e religioso. Il termine teocrazia sembra essere stato coniato da Giuseppe Flavio per
distinguere il particolare regime politico del popolo ebraico dalle altre forme di
governo teorizzate da Aristotele: la monarchia, l’aristocrazia e la democrazia. Gli
uomini investiti di fatto del potere, in quanto delegati da Dio, possono essere uomini
singoli, anche appartenenti a dinastie ereditarie, oppure un sacerdote o una casta
sacerdotale (ierocrazia). Le due forme di teocrazia possono anche coesistere. Nella
storia delle dottrine politiche s’intende per dottrina teocratica quella cristiana
dell’origine divina del potere, fondata sul celebre passo di Paolo: « omnis potestas a
Deo » (Rom., 13, 1-2), la cui interpretazione variò fortemente attraverso i secoli,
oscillando fra l’attribuzione al sovrano della responsabilità solo di fronte a Dio
(interpretazione teocratica del primo tipo), con conseguente sottomissione della
Chiesa al sovrano nel campo politico; e l’affermazione del dominio universale del
papa, nella sua qualità di capo dell’organismo attraverso il quale il volere di Dio si
attua sulla Terra (interpretazione ierocratica), Quest’ultima tendenza prevale nel
pensiero della patristica e della prima scolastica; le teorie della superiorità del
potere spirituale su quello temporale trionfarono specialmente sotto Gregorio VII,