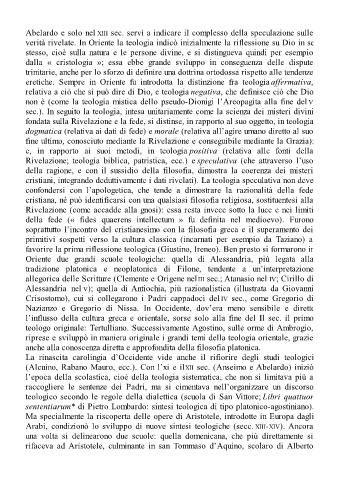Page 829 - Dizionario di Filosofia
P. 829
Abelardo e solo nel XIII sec. servì a indicare il complesso della speculazione sulle
verità rivelate. In Oriente la teologia indicò inizialmente la riflessione su Dio in se
stesso, cioè sulla natura e le persone divine, e si distingueva quindi per esempio
dalla « cristologia »; essa ebbe grande sviluppo in conseguenza delle dispute
trinitarie, anche per lo sforzo di definire una dottrina ortodossa rispetto alle tendenze
eretiche. Sempre in Oriente fu introdotta la distinzione fra teologia affermativa,
relativa a ciò che si può dire di Dio, e teologia negativa, che definisce ciò che Dio
non è (come la teologia mistica dello pseudo-Dionigi l’Areopagita alla fine del V
sec.). In seguito la teologia, intesa unitariamente come la scienza dei misteri divini
fondata sulla Rivelazione e la fede, si distinse, in rapporto al suo oggetto, in teologia
dogmatica (relativa ai dati di fede) e morale (relativa all’agire umano diretto al suo
fine ultimo, conosciuto mediante la Rivelazione e conseguibile mediante la Grazia);
e, in rapporto ai suoi metodi, in teologia positiva (relativa alle fonti della
Rivelazione; teologia biblica, patristica, ecc.) e speculativa (che attraverso l’uso
della ragione, e con il sussidio della filosofia, dimostra la coerenza dei misteri
cristiani, integrando deduttivamente i dati rivelati). La teologia speculativa non deve
confondersi con l’apologetica, che tende a dimostrare la razionalità della fede
cristiana, né può identificarsi con una qualsiasi filosofia religiosa, sostituentesi alla
Rivelazione (come accadde alla gnosi): essa resta invece sotto la luce e nei limiti
della fede (« fides quaerens intellectum » fu definita nel medioevo). Furono
soprattutto l’incontro del cristianesimo con la filosofia greca e il superamento dei
primitivi sospetti verso la cultura classica (incarnati per esempio da Taziano) a
favorire la prima riflessione teologica (Giustino, Ireneo). Ben presto si formarono in
Oriente due grandi scuole teologiche: quella di Alessandria, più legata alla
tradizione platonica e neoplatonica di Filone, tendente a un’interpretazione
allegorica delle Scritture (Clemente e Origene nel III sec.; Atanasio nel IV; Cirillo di
Alessandria nel V); quella di Antiochia, più razionalistica (illustrata da Giovanni
Crisostomo), cui si collegarono i Padri cappadoci del IV sec., come Gregorio di
Nazianzo e Gregorio di Nissa. In Occidente, dov’era meno sensibile e diretto
l’influsso della cultura greca e orientale, sorse solo alla fine del Il sec. il primo
teologo originale: Tertulliano. Successivamente Agostino, sulle orme di Ambrogio,
riprese e sviluppò in maniera originale i grandi temi della teologia orientale, grazie
anche alla conoscenza diretta e approfondita della filosofia platonica.
La rinascita carolingia d’Occidente vide anche il rifiorire degli studi teologici
(Alcuino, Rabano Mauro, ecc.). Con l’xi e il XII sec. (Anseimo e Abelardo) iniziò
l’epoca della scolastica, cioè della teologia sistematica, che non si limitava più a
raccogliere le sentenze dei Padri, ma si cimentava nell’organizzare un discorso
teologico secondo le regole della dialettica (scuola di San Vittore; Libri quattuor
sententiarum* di Pietro Lombardo: sintesi teologica di tipo platonico-agostiniano).
Ma specialmente la riscoperta delle opere di Aristotele, introdotte in Europa dagli
Arabi, condizionò lo sviluppo di nuove sintesi teologiche (secc. XIII-XIV). Ancora
una volta si delinearono due scuole: quella domenicana, che più direttamente si
rifaceva ad Aristotele, culminante in san Tommaso d’Aquino, scolaro di Alberto