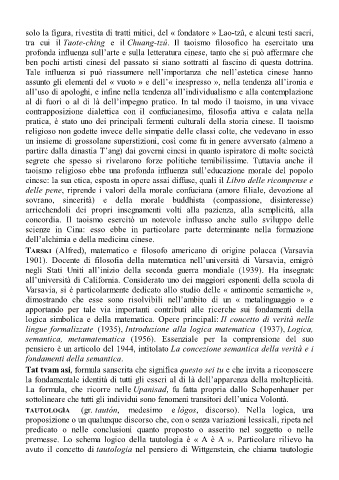Page 822 - Dizionario di Filosofia
P. 822
solo la figura, rivestita di tratti mitici, del « fondatore » Lao-tzû, e alcuni testi sacri,
tra cui il Taote-ching e il Chuang-tzû. Il taoismo filosofico ha esercitato una
profonda influenza sull’arte e sulla letteratura cinese, tanto che si può affermare che
ben pochi artisti cinesi del passato si siano sottratti al fascino di questa dottrina.
Tale influenza si può riassumere nell’importanza che nell’estetica cinese hanno
assunto gli elementi del « vuoto » e dell’« inespresso », nella tendenza all’ironia e
all’uso di apologhi, e infine nella tendenza all’individualismo e alla contemplazione
al di fuori o al di là dell’impegno pratico. In tal modo il taoismo, in una vivace
contrapposizione dialettica con il confucianesimo, filosofia attiva e calata nella
pratica, è stato uno dei principali fermenti culturali della storia cinese. Il taoismo
religioso non godette invece delle simpatie delle classi colte, che vedevano in esso
un insieme di grossolane superstizioni, così come fu in genere avversato (almeno a
partire dalla dinastia T’ang) dai governi cinesi in quanto ispiratore di molte società
segrete che spesso si rivelarono forze politiche temibilissime. Tuttavia anche il
taoismo religioso ebbe una profonda influenza sull’educazione morale del popolo
cinese: la sua etica, esposta in opere assai diffuse, quali il Libro delle ricompense e
delle pene, riprende i valori della morale confuciana (amore filiale, devozione al
sovrano, sincerità) e della morale buddhista (compassione, disinteresse)
arricchendoli dei propri insegnamenti volti alla pazienza, alla semplicità, alla
concordia. Il taoismo esercitò un notevole influsso anche sullo sviluppo delle
scienze in Cina: esso ebbe in particolare parte determinante nella formazione
dell’alchimia e della medicina cinese.
TARSKI (Alfred), matematico e filosofo americano di origine polacca (Varsavia
1901). Docente di filosofia della matematica nell’università di Varsavia, emigrò
negli Stati Uniti all’inizio della seconda guerra mondiale (1939). Ha insegnato
all’università di California. Considerato uno dei maggiori esponenti della scuola di
Varsavia, si è particolarmente dedicato allo studio delle « antinomie semantiche »,
dimostrando che esse sono risolvibili nell’ambito di un « metalinguaggio » e
apportando per tale via importanti contributi alle ricerche sui fondamenti della
logica simbolica e della matematica. Opere principali: Il concetto di verità nelle
lingue formalizzate (1935), Introduzione alla logica matematica (1937), Logica,
semantica, metamatematica (1956). Essenziale per la comprensione del suo
pensiero è un articolo del 1944, intitolato La concezione semantica della verità e i
fondamenti della semantica.
Tat tvam asi, formula sanscrita che significa questo sei tu e che invita a riconoscere
la fondamentale identità di tutti gli esseri al di là dell’apparenza della molteplicità.
La formula, che ricorre nelle Upanisad, fu fatta propria dallo Schopenhauer per
sottolineare che tutti gli individui sono fenomeni transitori dell’unica Volontà.
TAUTOLOGÌA (gr. tautón, medesimo e lògos, discorso). Nella logica, una
proposizione o un qualunque discorso che, con o senza variazioni lessicali, ripeta nel
predicato o nelle conclusioni quanto proposto o asserito nel soggetto o nelle
premesse. Lo schema logico della tautologia è « A è A ». Particolare rilievo ha
avuto il concetto di tautologia nel pensiero di Wittgenstein, che chiama tautologie