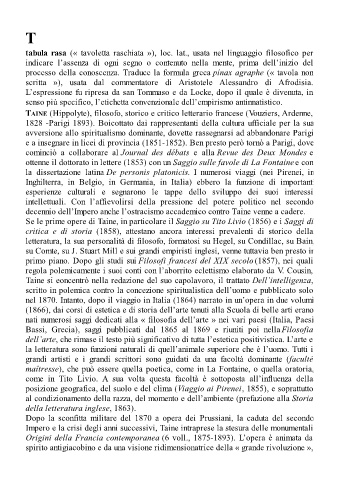Page 820 - Dizionario di Filosofia
P. 820
T
tabula rasa (« tavoletta raschiata »), loc. lat., usata nel linguaggio filosofico per
indicare l’assenza di ogni segno o contenuto nella mente, prima dell’inizio del
processo della conoscenza. Traduce la formula greca pínax agraphe (« tavola non
scritta »), usata dal commentatore di Aristotele Alessandro di Afrodisia.
L’espressione fu ripresa da san Tommaso e da Locke, dopo il quale è divenuta, in
senso più specifico, l’etichetta convenzionale dell’empirismo antinnatistico.
TAINE (Hippolyte), filosofo, storico e critico letterario francese (Vouziers, Ardenne,
1828 -Parigi 1893). Boicottato dai rappresentanti della cultura ufficiale per la sua
avversione allo spiritualismo dominante, dovette rassegnarsi ad abbandonare Parigi
e a insegnare in licei di provincia (1851-1852). Ben presto però tornò a Parigi, dove
cominciò a collaborare al Journal des débats e alla Revue des Deux Mondes e
ottenne il dottorato in lettere (1853) con un Saggio sulle favole di La Fontaine e con
la dissertazione latina De personis platonicis. I numerosi viaggi (nei Pirenei, in
Inghilterra, in Belgio, in Germania, in Italia) ebbero la funzione di importanti
esperienze culturali e segnarono le tappe dello sviluppo dei suoi interessi
intellettuali. Con l’affievolirsi della pressione del potere politico nel secondo
decennio dell’Impero anche l’ostracismo accademico contro Taine venne a cadere.
Se le prime opere di Taine, in particolare il Saggio su Tito Livio (1856) e i Saggi di
critica e di storia (1858), attestano ancora interessi prevalenti di storico della
letteratura, la sua personalità di filosofo, formatosi su Hegel, su Condillac, su Bain,
su Comte, su J. Stuart Mill e sui grandi empiristi inglesi, venne tuttavia ben presto in
primo piano. Dopo gli studi sui Filosofi francesi del XIX secolo (1857), nei quali
regola polemicamente i suoi conti con l’aborrito eclettismo elaborato da V. Cousin,
Taine si eoncentrò nella redazione del suo capolavoro, il trattato Dell’intelligenza,
scritto in polemica contro la concezione spiritualistica dell’uomo e pubblicato solo
nel 1870. Intanto, dopo il viaggio in Italia (1864) narrato in un’opera in due volumi
(1866), dai corsi di estetica e di storia dell’arte tenuti alla Scuola di belle arti erano
nati numerosi saggi dedicati alla « filosofia dell’arte » nei vari paesi (Italia, Paesi
Bassi, Grecia), saggi pubblicati dal 1865 al 1869 e riuniti poi nella Filosofia
dell’arte, che rimase il testo più significativo di tutta l’estetica positivistica. L’arte e
la letteratura sono funzioni naturali di quell’animale superiore che è l’uomo. Tutti i
grandi artisti e i grandi scrittori sono guidati da una facoltà dominante (faculté
maîtresse), che può essere quella poetica, come in La Fontaine, o quella oratoria,
come in Tito Livio. A sua volta questa facoltà è sottoposta all’influenza della
posizione geografica, del suolo e del clima (Viaggio ai Pirenei, 1855), e soprattutto
al condizionamento della razza, del momento e dell’ambiente (prefazione alla Storia
della letteratura inglese, 1863).
Dopo la sconfitta militare del 1870 a opera dei Prussiani, la caduta del secondo
Impero e la crisi degli anni successivi, Taine intraprese la stesura delle monumentali
Origini della Francia contemporanea (6 voll., 1875-1893). L’opera è animata da
spirito antigiacobino e da una visione ridimensionatrice della « grande rivoluzione »,