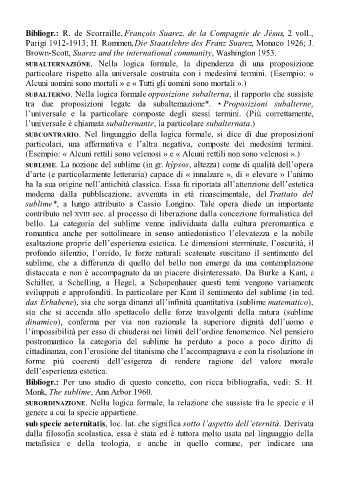Page 816 - Dizionario di Filosofia
P. 816
Bibliogr.: R. de Scorraille, François Suarez, de la Compagnie de Jésus, 2 voll.,
Parigi 1912-1913; H. Rommen, Die Staatslehre des Franz Suarez, Monaco 1926; J.
Brown-Scott, Suarez and the international community, Washington 1953.
SUBALTERNAZIÓNE. Nella logica formale, la dipendenza di una proposizione
particolare rispetto alla universale costruita con i medesimi termini. (Esempio: «
Alcuni uomini sono mortali » e « Tutti gli uomini sono mortali ».)
SUBALTERNO. Nella logica formale opposizione subalterna, il rapporto che sussiste
tra due proposizioni legate da subaltemazione*. • Proposizioni subalterne,
l’universale e la particolare composte degli stessi termini. (Più correttamente,
l’universale è chiamata subalternante, la particolare subalternata.)
SUBCONTRARIO. Nel linguaggio della logica formale, si dice di due proposizioni
particolari, una affermativa e l’altra negativa, composte dei medesimi termini.
(Esempio: « Alcuni rettili sono velenosi » e « Alcuni rettili non sono velenosi ».)
SUBLIME. La nozione del sublime (in gr. hýpsos, altezza) come di qualità dell’opera
d’arte (e particolarmente letteraria) capace di « innalzare », di « elevare » l’animo
ha la sua origine nell’antichità classica. Essa fu riportata all’attenzione dell’estetica
moderna dalla pubblicazione, avvenuta in età rinascimentale, del Trattato del
sublime*, a lungo attribuito a Cassio Longino. Tale opera diede un importante
contributo nel XVIII sec. al processo di liberazione dalla concezione formalistica del
bello. La categoria del sublime venne individuata dalla cultura preromantica e
romantica anche per sottolineare in senso antiedonistico l’elevatezza e la nobile
esaltazione proprie dell’esperienza estetica. Le dimensioni sterminate, l’oscurità, il
profondo silenzio, l’orrido, le forze naturali scatenate suscitano il sentimento del
sublime, che a differenza di quello del bello non emerge da una contemplazione
distaccata e non è accompagnato da un piacere disinteressato. Da Burke a Kant, a
Schiller, a Schelling, a Hegel, a Schopenhauer questi temi vengono variamente
sviluppati e approfonditi. In particolare per Kant il sentimento del sublime (in ted.
das Erhabene), sia che sorga dinanzi all’infinità quantitativa (sublime matematico),
sia che si accenda allo spettacolo delle forze travolgenti della natura (sublime
dinamico), conferma per via non razionale la superiore dignità dell’uomo e
l’impossibilità per esso di chiudersi nei limiti dell’ordine fenomenico. Nel pensiero
postromantico la categoria del sublime ha perduto a poco a poco diritto di
cittadinanza, con l’erosione del titanismo che l’accompagnava e con la risoluzione in
forme più coerenti dell’esigenza di rendere ragione del valore morale
dell’esperienza estetica.
Bibliogr.: Per uno studio di questo concetto, con ricca bibliografia, vedi: S. H.
Monk, The sublime, Ann Arbor 1960.
SUBORDINAZIONE. Nella logica formale, la relazione che sussiste fra le specie e il
genere a cui la specie appartiene.
sub specie aeternitatis, loc. lat. che significa sotto l’aspetto dell’eternità. Derivata
dalla filosofia scolastica, essa è stata ed è tuttora molto usata nel linguaggio della
metafisica e della teologia, e anche in quello comune, per indicare una