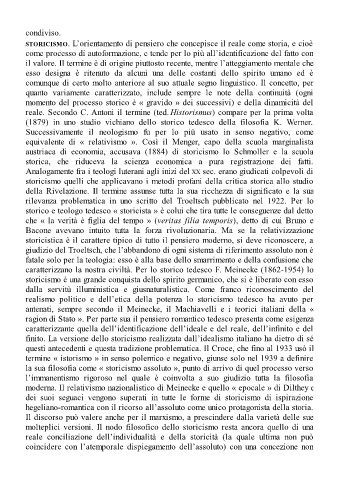Page 811 - Dizionario di Filosofia
P. 811
condiviso.
STORICISMO. L’orientamento di pensiero che concepisce il reale come storia, e cioè
come processo di autoformazione, e tende per lo più all’identificazione del fatto con
il valore. Il termine è di origine piuttosto recente, mentre l’atteggiamento mentale che
esso designa è ritenuto da alcuni una delle costanti dello spirito umano ed è
comunque di certo molto anteriore al suo attuale segno linguistico. Il concetto, per
quanto variamente caratterizzato, include sempre le note della continuità (ogni
momento del processo storico è « gravido » dei successivi) e della dinamicità del
reale. Secondo C. Antoni il termine (ted. Historismus) compare per la prima volta
(1879) in uno studio vichiano dello storico tedesco della filosofia K. Werner.
Successivamente il neologismo fu per lo più usato in senso negativo, come
equivalente di « relativismo ». Così il Menger, capo della scuola marginalista
austriaca di economia, accusava (1884) di storicismo lo Schmoller e la scuola
storica, che riduceva la scienza economica a pura registrazione dei fatti.
Analogamente fra i teologi luterani agli inizi del XX sec. erano giudicati colpevoli di
storicismo quelli che applicavano i metodi profani della critica storica allo studio
della Rivelazione. Il termine assunse tutta la sua ricchezza di significato e la sua
rilevanza problematica in uno scritto del Troeltsch pubblicato nel 1922. Per lo
storico e teologo tedesco « storicista » è colui che tira tutte le conseguenze dal detto
che « la verità è figlia del tempo » (veritas filia temporis), detto di cui Bruno e
Bacone avevano intuito tutta la forza rivoluzionaria. Ma se la relativizzazione
storicistica è il carattere tipico di tutto il pensiero moderno, si deve riconoscere, a
giudizio del Troeltsch, che l’abbandono di ogni sistema di riferimento assoluto non è
fatale solo per la teologia: esso è alla base dello smarrimento e della confusione che
caratterizzano la nostra civiltà. Per lo storico tedesco F. Meinecke (1862-1954) lo
storicismo è una grande conquista dello spirito germanico, che si è liberato con esso
dalla servitù illuministica e giusnaturalistica. Come franco riconoscimento del
realismo politico e dell’etica della potenza lo storicismo tedesco ha avuto per
antenati, sempre secondo il Meinecke, il Machiavelli e i teorici italiani della «
ragion di Stato ». Per parte sua il pensiero romantico tedesco presenta come esigenza
caratterizzante quella dell’identificazione dell’ideale e del reale, dell’infinito e del
finito. La versione dello storicismo realizzata dall’idealismo italiano ha dietro di sé
questi antecedenti e questa tradizione problematica. Il Croce, che fino al 1933 usò il
termine « istorismo » in senso polemico e negativo, giunse solo nel 1939 a definire
la sua filosofia come « storicismo assoluto », punto di arrivo di quel processo verso
l’immanentismo rigoroso nel quale è coinvolta a suo giudizio tutta la filosofia
moderna. Il relativismo nazionalistico di Meinecke e quello « epocale » di Dilthey e
dei suoi seguaci vengono superati in tutte le forme di storicismo di ispirazione
hegeliano-romantica con il ricorso all’assoluto come unico protagonista della storia.
Il discorso può valere anche per il marxismo, a prescindere dalla varietà delle sue
molteplici versioni. Il nodo filosofico dello storicismo resta ancora quello di una
reale conciliazione dell’individualità e della storicità (la quale ultima non può
coincidere con l’atemporale dispiegamento dell’assoluto) con una concezione non