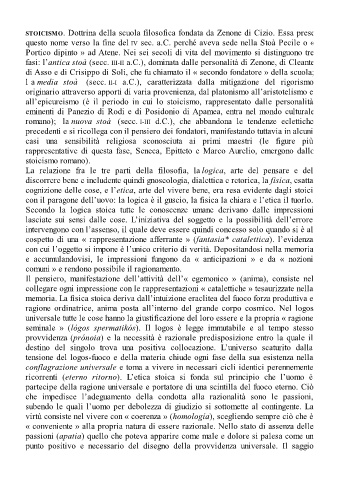Page 808 - Dizionario di Filosofia
P. 808
STOICISMO. Dottrina della scuola filosofica fondata da Zenone di Cizio. Essa prese
questo nome verso la fine del IV sec. a.C. perché aveva sede nella Stoà Pecile o «
Portico dipinto » ad Atene. Nei sei secoli di vita del movimento si distinguono tre
fasi: l’antica stoà (secc. III-II a.C.), dominata dalle personalità di Zenone, di Cleante
di Asso e di Crisippo di Soli, che fu chiamato il « secondo fondatore » della scuola;
l a media stoà (secc. II-I a.C.), caratterizzata dalla mitigazione del rigorismo
originario attraverso apporti di varia provenienza, dal platonismo all’aristotelismo e
all’epicureismo (è il periodo in cui lo stoicismo, rappresentato dalle personalità
eminenti di Panezio di Rodi e di Posidonio di Apamea, entra nel mondo culturale
romano); la nuova stoà (secc. I-III d.C.), che abbandona le tendenze eclettiche
precedenti e si ricollega con il pensiero dei fondatori, manifestando tuttavia in alcuni
casi una sensibilità religiosa sconosciuta ai primi maestri (le figure più
rappresentative di questa fase, Seneca, Epitteto e Marco Aurelio, emergono dallo
stoicismo romano).
La relazione fra le tre parti della filosofìa, la logica, arte del pensare e del
discorrere bene e includente quindi gnoseologia, dialettica e retorica, la fisica, esatta
cognizione delle cose, e l’etica, arte del vivere bene, era resa evidente dagli stoici
con il paragone dell’uovo: la logica è il guscio, la fisica la chiara e l’etica il tuorlo.
Secondo la logica stoica tutte le conoscenze umane derivano dalle impressioni
lasciate sui sensi dalle cose. L’iniziativa del soggetto e la possibilità dell’errore
intervengono con l’assenso, il quale deve essere quindi concesso solo quando si è al
cospetto di una « rappresentazione afferrante » (fantasia* catalettica). l’evidenza
con cui l’oggetto si impone è l’unico criterio di verità. Depositandosi nella memoria
e accumulandovisi, le impressioni fungono da « anticipazioni » e da « nozioni
comuni » e rendono possibile il ragionamento.
Il pensiero, manifestazione dell’attività dell’« egemonico » (anima), consiste nel
collegare ogni impressione con le rappresentazioni « catalettiche » tesaurizzate nella
memoria. La fìsica stoica deriva dall’intuizione eraclitea del fuoco forza produttiva e
ragione ordinatrice, anima posta all’interno del grande corpo cosmico. Nel logos
universale tutte le cose hanno la giustificazione del loro essere e la propria « ragione
seminale » (lógos spermatikós). Il logos è legge immutabile e al tempo stesso
provvidenza (prónoia) e la necessità è razionale predisposizione entro la quale il
destino del singolo trova una positiva collocazione. L’universo scaturito dalla
tensione del logos-fuoco e della materia chiude ogni fase della sua esistenza nella
conflagrazione universale e toma a vivere in necessari cicli identici perennemente
ricorrenti (eterno ritorno). L’etica stoica si fonda sul principio che l’uomo è
partecipe della ragione universale e portatore di una scintilla del fuoco eterno. Ciò
che impedisce l’adeguamento della condotta alla razionalità sono le passioni,
subendo le quali l’uomo per debolezza di giudizio si sottomette al contingente. La
virtù consiste nel vivere con « coerenza » (homología), scegliendo sempre ciò che è
« conveniente » alla propria natura di essere razionale. Nello stato di assenza delle
passioni (apatia) quello che poteva apparire come male e dolore si palesa come un
punto positivo e necessario del disegno della provvidenza universale. Il saggio