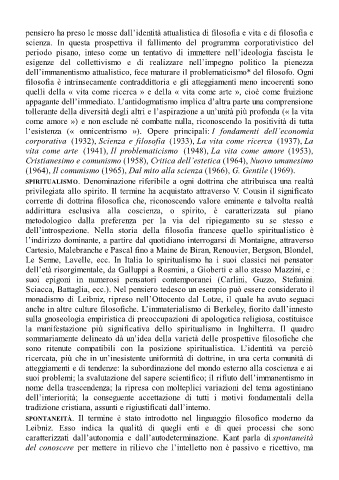Page 805 - Dizionario di Filosofia
P. 805
pensiero ha preso le mosse dall’identità attualistica di filosofia e vita e di filosofia e
scienza. In questa prospettiva il fallimento del programma corporativistico del
periodo pisano, inteso come un tentativo di immettere nell’ideologia fascista le
esigenze del collettivismo e di realizzare nell’impegno politico la pienezza
dell’immanentismo attualistico, fece maturare il problematicismo* del filosofo. Ogni
filosofia è intrinsecamente contraddittoria e gli atteggiamenti meno incoerenti sono
quelli della « vita come ricerca » e della « vita come arte », cioè come fruizione
appagante dell’immediato. L’antidogmatismo implica d’altra parte una comprensione
tollerante della diversità degli altri e l’aspirazione a un’unità più profonda (« la vita
come amore ») e non esclude né combatte nulla, riconoscendo la positività di tutta
l‘esistenza (« onnicentrismo »). Opere principali: I fondamenti dell’economìa
corporativa (1932), Scienza e filosofia (1933), La vita come ricerca (1937), La
vita come arte (1941), Il problematicismo (1948), La vita come amore (1953),
Cristianesimo e comunismo (1958), Critica dell’estetica (1964), Nuovo umanesimo
(1964), Il comunismo (1965), Dal mito alla scienza (1966), G. Gentile (1969).
SPIRITUALISMO. Denominazione riferibile a ogni dottrina che attribuisca una realtà
privilegiata allo spirito. Il termine ha acquistato attraverso V. Cousin il significato
corrente di dottrina filosofica che, riconoscendo valore eminente e talvolta realtà
addirittura esclusiva alla coscienza, o spirito, è caratterizzata sul piano
metodologico dalla preferenza per la via del ripiegamento su se stesso e
dell’introspezione. Nella storia della filosofia francese quello spiritualistico è
l’indirizzo dominante, a partire dal quotidiano interrogarsi di Montaigne, attraverso
Cartesio, Malebranche e Pascal fino a Maine de Biran, Renouvier, Bergson, Blondel,
Le Senne, Lavelle, ecc. In Italia lo spiritualismo ha i suoi classici nei pensatori
dell’età risorgimentale, da Galluppi a Rosmini, a Gioberti e allo stesso Mazzini, e i
suoi epigoni in numerosi pensatori contemporanei (Carlini, Guzzo, Stefanini,
Sciacca, Battaglia, ecc.). Nel pensiero tedesco un esempio può essere considerato il
monadismo di Leibniz, ripreso nell’Ottocento dal Lotze, il quale ha avuto seguaci
anche in altre culture filosofiche. L’immaterialismo di Berkeley, fiorito dall’innesto
sulla gnoseologia empiristica di preoccupazioni di apologetica religiosa, costituisce
la manifestazione più significativa dello spiritualismo in Inghilterra. Il quadro
sommariamente delineato dà un’idea della varietà delle prospettive filosofiche che
sono ritenute compatibili con la posizione spiritualistica. L’identità va perciò
ricercata, più che in un’inesistente uniformità di dottrine, in una certa comunità di
atteggiamenti e di tendenze: la subordinazione del mondo esterno alla coscienza e ai
suoi problemi; la svalutazione del sapere scientifico; il rifiuto dell’immanentismo in
nome della trascendenza; la ripresa con molteplici variazioni del tema agostiniano
dell’interiorità; la conseguente accettazione di tutti i motivi fondamentali della
tradizione cristiana, assunti e rigiustificati dall’intemo.
SPONTANEITÀ. Il termine è stato introdotto nel linguaggio filosofico moderno da
Leibniz. Esso indica la qualità di quegli enti e di quei processi che sono
caratterizzati dall’autonomia e dall’autodeterminazione. Kant parla di spontaneità
del conoscere per mettere in rilievo che l’intelletto non è passivo e ricettivo, ma