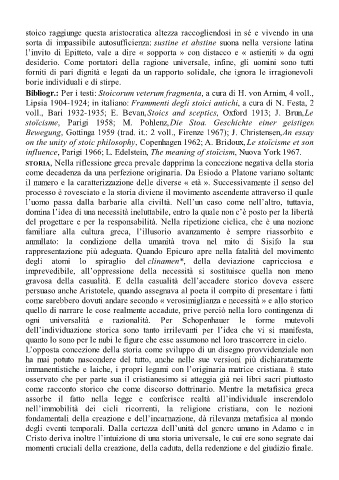Page 809 - Dizionario di Filosofia
P. 809
stoico raggiunge questa aristocratica altezza raccogliendosi in sé e vivendo in una
sorta di impassibile autosufficienza: sustine et abstine suona nella versione latina
l’invito di Epitteto, vale a dire « sopporta » con distacco e « astieniti » da ogni
desiderio. Come portatori della ragione universale, infine, gli uomini sono tutti
forniti di pari dignità e legati da un rapporto solidale, che ignora le irragionevoli
borie individuali e di stirpe.
Bibliogr.: Per i testi: Stoicorum veterum fragmenta, a cura di H. von Arnim, 4 voll.,
Lipsia 1904-1924; in italiano: Frammenti degli stoici antichi, a cura di N. Festa, 2
voll., Bari 1932-1935; E. Bevan, Stoics and sceptics, Oxford 1913; J. Brun, Le
stoïcisme, Parigi 1958; M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen
Bewegung, Gottinga 1959 (trad. it.: 2 voll., Firenze 1967); J. Christensen, An essay
on the unity of stoic philosophy, Copenhagen 1962; A. Bridoux, Le stoïcisme et son
influence, Parigi 1966; L. Edelstein, The meaning of stoïcism, Nuova York 1967.
STORIA, Nella riflessione greca prevale dapprima la concezione negativa della storia
come decadenza da una perfezione originaria. Da Esiodo a Platone variano soltanto
il numero e la caratterizzazione delle diverse « età ». Successivamente il senso del
processo è rovesciato e la storia diviene il movimento ascendente attraverso il quale
l’uomo passa dalla barbarie alla civiltà. Nell’un caso come nell’altro, tuttavia,
domina l’idea di una necessità ineluttabile, entro la quale non c’è posto per la libertà
del progettare e per la responsabilità. Nella ripetizione ciclica, che è una nozione
familiare alla cultura greca, l’illusorio avanzamento è sempre riassorbito e
annullato: la condizione della umanità trova nel mito di Sisifo la sua
rappresentazione più adeguata. Quando Epicuro apre nella fatalità del movimento
degli atomi lo spiraglio del clinamen*, della deviazione capricciosa e
imprevedibile, all’oppressione della necessità si sostituisce quella non meno
gravosa della casualità. E della casualità dell’accadere storico doveva essere
persuaso anche Aristotele, quando assegnava al poeta il compito di presentare i fatti
come sarebbero dovuti andare secondo « verosimiglianza e necessità » e allo storico
quello di narrare le cose realmente accadute, prive perciò nella loro contingenza di
ogni universalità e razionalità. Per Schopenhauer le forme mutevoli
dell’individuazione storica sono tanto irrilevanti per l’idea che vi si manifesta,
quanto lo sono per le nubi le figure che esse assumono nel loro trascorrere in cielo.
L’opposta concezione della storia come sviluppo di un disegno provvidenziale non
ha mai potuto nascondere del tutto, anche nelle sue versioni più dichiaratamente
immanentistiche e laiche, i propri legami con l’originaria matrice cristiana. È stato
osservato che per parte sua il cristianesimo si atteggia già nei libri sacri piuttosto
come racconto storico che come discorso dottrinario. Mentre la metafisica greca
assorbe il fatto nella legge e conferisce realtà all’individuale inserendolo
nell’immobilità dei cicli ricorrenti, la religione cristiana, con le nozioni
fondamentali della creazione e dell’incarnazione, dà rilevanza metafisica al mondo
degli eventi temporali. Dalla certezza dell’unità del genere umano in Adamo e in
Cristo deriva inoltre l’intuizione di una storia universale, le cui ere sono segnate dai
momenti cruciali della creazione, della caduta, della redenzione e del giudizio finale.