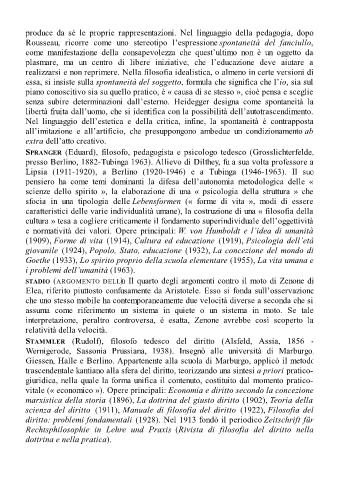Page 806 - Dizionario di Filosofia
P. 806
produce da sé le proprie rappresentazioni. Nel linguaggio della pedagogia, dopo
Rousseau, ricorre come uno stereotipo l’espressione spontaneità del fanciullo,
come manifestazione della consapevolezza che quest’ultimo non è un oggetto da
plasmare, ma un centro di libere iniziative, che l’educazione deve aiutare a
realizzarsi e non reprimere. Nella filosofia idealistica, o almeno in certe versioni di
essa, si insiste sulla spontaneità del soggetto, formula che significa che l’io, sia sul
piano conoscitivo sia su quello pratico, è « causa di se stesso », cioè pensa e sceglie
senza subire determinazioni dall’esterno. Heidegger designa come spontaneità la
libertà fruita dall’uomo, che si identifica con la possibilità dell’autotrascendimento.
Nel linguaggio dell’estetica e della critica, infine, la spontaneità è contrapposta
all’imitazione e all’artificio, che presuppongono ambedue un condizionamento ab
extra dell’atto creativo.
SPRANGER (Eduard), filosofo, pedagogista e psicologo tedesco (Grosslichterfelde,
presso Berlino, 1882-Tubinga 1963). Allievo di Dilthey, fu a sua volta professore a
Lipsia (1911-1920), a Berlino (1920-1946) e a Tubinga (1946-1963). Il suo
pensiero ha come temi dominanti la difesa dell’autonomia metodologica delle «
scienze dello spirito », la elaborazione di una « psicologia della struttura » che
sfocia in una tipologia delle Lebensformen (« forme di vita », modi di essere
caratteristici delle varie individualità umane), la costruzione di una « filosofia della
cultura » tesa a cogliere criticamente il fondamento superindividuale dell’oggettività
e normatività dei valori. Opere principali: W. von Humboldt e l’idea di umanità
(1909), Forme di vita (1914), Cultura ed educazione (1919), Psicologia dell’età
giovanile (1924), Popolo, Stato, educazione (1932), La concezione del mondo di
Goethe (1933), Lo spirito proprio della scuola elementare (1955), La vita umana e
i problemi dell’umanità (1963).
STADIO (ARGOMENTO DELLO). Il quarto degli argomenti contro il moto di Zenone di
Elea, riferito piuttosto confusamente da Aristotele. Esso si fonda sull’osservazione
che uno stesso mobile ha contemporaneamente due velocità diverse a seconda che si
assuma come riferimento un sistema in quiete o un sistema in moto. Se tale
interpretazione, peraltro controversa, è esatta, Zenone avrebbe così scoperto la
relatività della velocità.
STAMMLER (Rudolf), filosofo tedesco del diritto (Alsfeld, Assia, 1856 -
Wernigerode, Sassonia Prussiana, 1938). Insegnò alle università di Marburgo,
Giessen, Halle e Berlino. Appartenente alla scuola di Marburgo, applicò il metodo
trascendentale kantiano alla sfera del diritto, teorizzando una sintesi a priori pratico-
giuridica, nella quale la forma unifica il contenuto, costituito dal momento pratico-
vitale (« economico »). Opere principali: Economia e diritto secondo la concezione
marxistica della storia (1896), La dottrina del giusto diritto (1902), Teoria della
scienza del diritto (1911), Manuale di filosofia del diritto (1922), Filosofia del
diritto: problemi fondamentali (1928). Nel 1913 fondò il periodico Zeitschrift für
Rechtsphilosophie in Lehre und Praxis (Rivista di filosofia del diritto nella
dottrina e nella pratica).