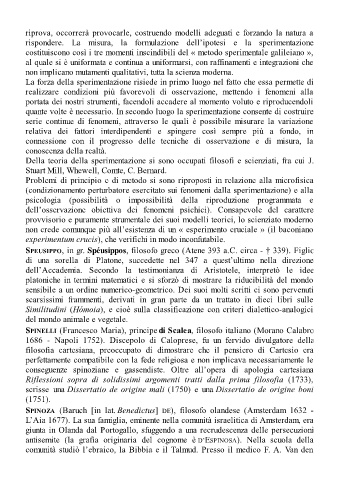Page 801 - Dizionario di Filosofia
P. 801
riprova, occorrerà provocarle, costruendo modelli adeguati e forzando la natura a
rispondere. La misura, la formulazione dell’ipotesi e la sperimentazione
costituiscono così i tre momenti inscindibili del « metodo sperimentale galileiano »,
al quale si è uniformata e continua a uniformarsi, con raffinamenti e integrazioni che
non implicano mutamenti qualitativi, tutta la scienza moderna.
La forza della sperimentazione risiede in primo luogo nel fatto che essa permette di
realizzare condizioni più favorevoli di osservazione, mettendo i fenomeni alla
portata dei nostri strumenti, facendoli accadere al momento voluto e riproducendoli
quante volte è necessario. In secondo luogo la sperimentazione consente di costruire
serie continue di fenomeni, attraverso le quali è possibile misurare la variazione
relativa dei fattori interdipendenti e spingere così sempre più a fondo, in
connessione con il progresso delle tecniche di osservazione e di misura, la
conoscenza della realtà.
Della teoria della sperimentazione si sono occupati filosofi e scienziati, fra cui J.
Stuart Mill, Whewell, Comte, C. Bernard.
Problemi di principio e di metodo si sono riproposti in relazione alla microfisica
(condizionamento perturbatore esercitato sui fenomeni dalla sperimentazione) e alla
psicologia (possibilità o impossibilità della riproduzione programmata e
dell’osservazione obiettiva dei fenomeni psichici). Consapevole del carattere
provvisorio e puramente strumentale dei suoi modelli teorici, lo scienziato moderno
non crede comunque più all’esistenza di un « esperimento cruciale » (il baconiano
experimentum crucis), che verifichi in modo inconfutabile.
SPEUSIPPO, in gr. Spéusippos, filosofo greco (Atene 393 a.C. circa - † 339). Figlio
di una sorella di Platone, succedette nel 347 a quest’ultimo nella direzione
dell’Accademia. Secondo la testimonianza di Aristotele, interpretò le idee
platoniche in termini matematici e si sforzò di mostrare la riducibilità del mondo
sensibile a un ordine numerico-geometrico. Dei suoi molti scritti ci sono pervenuti
scarsissimi frammenti, derivati in gran parte da un trattato in dieci libri sulle
Similitudini (Hómoia), e cioè sulla classificazione con criteri dialettico-analogici
del mondo animale e vegetale.
SPINELLI (Francesco Maria), principe di Scalea, filosofo italiano (Morano Calabro
1686 - Napoli 1752). Discepolo di Caloprese, fu un fervido divulgatore della
filosofia cartesiana, preoccupato di dimostrare che il pensiero di Cartesio era
perfettamente compatibile con la fede religiosa e non implicava necessariamente le
conseguenze spinoziane e gassendiste. Oltre all’opera di apologia cartesiana
Riflessioni sopra di solidissimi argomenti tratti dalla prima filosofia (1733),
scrisse una Dissertatio de origine mali (1750) e una Dissertatio de origine boni
(1751).
SPINOZA (Baruch [in lat. Benedictus] DE), filosofo olandese (Amsterdam 1632 -
L’Aia 1677). La sua famiglia, eminente nella comunità israelitica di Amsterdam, era
giunta in Olanda dal Portogallo, sfuggendo a una recrudescenza delle persecuzioni
antisemite (la grafìa originaria del cognome è D’ESPINOSA). Nella scuola della
comunità studiò l’ebraico, la Bibbia e il Talmud. Presso il medico F. A. Van den