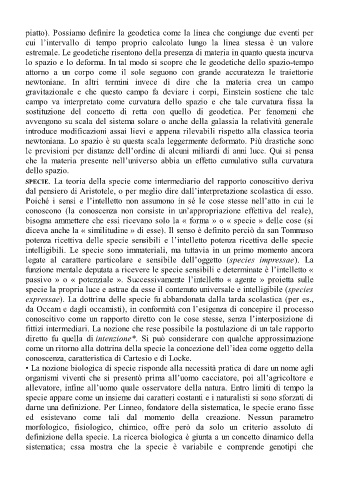Page 797 - Dizionario di Filosofia
P. 797
piatto). Possiamo definire la geodetica come la linea che congiunge due eventi per
cui l’intervallo di tempo proprio calcolato lungo la linea stessa è un valore
estremale. Le geodetiche risentono della presenza di materia in quanto questa incurva
lo spazio e lo deforma. In tal modo si scopre che le geodetiche dello spazio-tempo
attorno a un corpo come il sole seguono con grande accuratezza le traiettorie
newtoniane. In altri termini invece di dire che la materia crea un campo
gravitazionale e che questo campo fa deviare i corpi, Einstein sostiene che tale
campo va interpretato come curvatura dello spazio e che tale curvatura fissa la
sostituzione del concetto di retta con quello di geodetica. Per fenomeni che
avvengono su scala del sistema solare o anche della galassia la relatività generale
introduce modificazioni assai lievi e appena rilevabili rispetto alla classica teoria
newtoniana. Lo spazio è su questa scala leggermente deformato. Più drastiche sono
le previsioni per distanze dell’ordine di alcuni miliardi di anni luce. Qui si pensa
che la materia presente nell’universo abbia un effetto cumulativo sulla curvatura
dello spazio.
SPECIE. La teoria della specie come intermediario del rapporto conoscitivo deriva
dal pensiero di Aristotele, o per meglio dire dall’interpretazione scolastica di esso.
Poiché i sensi e l’intelletto non assumono in sé le cose stesse nell’atto in cui le
conoscono (la conoscenza non consiste in un’appropriazione effettiva del reale),
bisogna ammettere che essi ricevano solo la « forma » o « specie » delle cose (si
diceva anche la « similitudine » di esse). Il senso è definito perciò da san Tommaso
potenza ricettiva delle specie sensibili e l’intelletto potenza ricettiva delle specie
intelligibili. Le specie sono immateriali, ma tuttavia in un primo momento ancora
legate al carattere particolare e sensibile dell’oggetto (species impressae). La
funzione mentale deputata a ricevere le specie sensibili e determinate è l’intelletto «
passivo » o « potenziale ». Successivamente l’intelletto « agente » proietta sulle
specie la propria luce e astrae da esse il contenuto universale e intelligibile (species
expressae). La dottrina delle specie fu abbandonata dalla tarda scolastica (per es.,
da Occam e dagli occamisti), in conformità con l’esigenza di concepire il processo
conoscitivo come un rapporto diretto con le cose stesse, senza l’interposizione di
fittizi intermediari. La nozione che rese possibile la postulazione di un tale rapporto
diretto fu quella di intenzione*. Si può considerare con qualche approssimazione
come un ritorno alla dottrina della specie la concezione dell’idea come oggetto della
conoscenza, caratteristica di Cartesio e di Locke.
• La nozione biologica di specie risponde alla necessità pratica di dare un nome agli
organismi viventi che si presentò prima all’uomo cacciatore, poi all’agricoltore e
allevatore, infine all’uomo quale osservatore della natura. Entro limiti di tempo la
specie appare come un insieme dai caratteri costanti e i naturalisti si sono sforzati di
darne una definizione. Per Linneo, fondatore della sistematica, le specie erano fisse
ed esistevano come tali dal momento della creazione. Nessun parametro
morfologico, fisiologico, chimico, offre però da solo un criterio assoluto di
definizione della specie. La ricerca biologica è giunta a un concetto dinamico della
sistematica; cssa mostra che la specie è variabile e comprende genotipi che