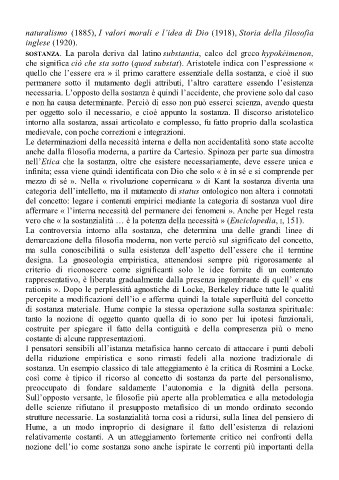Page 793 - Dizionario di Filosofia
P. 793
naturalismo (1885), I valori morali e l’idea di Dio (1918), Storia della filosofia
inglese (1920).
SOSTANZA. La parola deriva dal latino substantia, calco del greco hypokéimenon,
che significa ciò che sta sotto (quod substat). Aristotele indica con l’espressione «
quello che l’essere era » il primo carattere essenziale della sostanza, e cioè il suo
permanere sotto il mutamento degli attributi, l’altro carattere essendo l’esistenza
necessaria. L’opposto della sostanza è quindi l’accidente, che proviene solo dal caso
e non ha causa determinante. Perciò di esso non può esserci scienza, avendo questa
per oggetto solo il necessario, e cioè appunto la sostanza. Il discorso aristotelico
intorno alla sostanza, assai articolato e complesso, fu fatto proprio dalla scolastica
medievale, con poche correzioni e integrazioni.
Le determinazioni della necessità interna e della non accidentalità sono state accolte
anche dalla filosofia moderna, a partire da Cartesio. Spinoza per parte sua dimostra
nell’Etica che la sostanza, oltre che esistere necessariamente, deve essere unica e
infinita; essa viene quindi identificata con Dio che solo « è in sé e si comprende per
mezzo di sé ». Nella « rivoluzione copernicana » di Kant la sostanza diventa una
categoria dell’intelletto, ma il mutamento di status ontologico non altera i connotati
del concetto: legare i contenuti empirici mediante la categoria di sostanza vuol dire
affermare « l’interna necessità del permanere dei fenomeni ». Anche per Hegel resta
vero che « la sostanzialità … è la potenza della necessità » (Enciclopedia, I, 151).
La controversia intorno alla sostanza, che determina una delle grandi linee di
demarcazione della filosofia moderna, non verte perciò sul significato del concetto,
ma sulla conoscibilità o sulla esistenza dell’aspetto dell’essere che il termine
designa. La gnoseologia empiristica, attenendosi sempre più rigorosamente al
criterio di riconoscere come significanti solo le idee fornite di un contenuto
rappresentativo, è liberata gradualmente dalla presenza ingombrante di quell’ « ens
rationis ». Dopo le perplessità agnostiche di Locke, Berkeley riduce tutte le qualità
percepite a modificazioni dell’io e afferma quindi la totale superfluità del concetto
di sostanza materiale. Hume compie la stessa operazione sulla sostanza spirituale:
tanto la nozione di oggetto quanto quella di io sono per lui ipotesi funzionali,
costruite per spiegare il fatto della contiguità e della compresenza più o meno
costante di alcune rappresentazioni.
I pensatori sensibili all’istanza metafisica hanno cercato di attaccare i punti deboli
della riduzione empiristica e sono rimasti fedeli alla nozione tradizionale di
sostanza. Un esempio classico di tale atteggiamento è la critica di Rosmini a Locke,
così come è tipico il ricorso al concetto di sostanza da parte del personalismo,
preoccupato di fondare saldamente l’autonomia e la dignità della persona.
Sull’opposto versante, le filosofie più aperte alla problematica e alla metodologia
delle scienze rifiutano il presupposto metafìsico di un mondo ordinato secondo
strutture necessarie. La sostanzialità torna così a ridursi, sulla linea del pensiero di
Hume, a un modo improprio di designare il fatto dell’esistenza di relazioni
relativamente costanti. A un atteggiamento fortemente critico nei confronti della
nozione dell’io come sostanza sono anche ispirate le correnti più importanti della