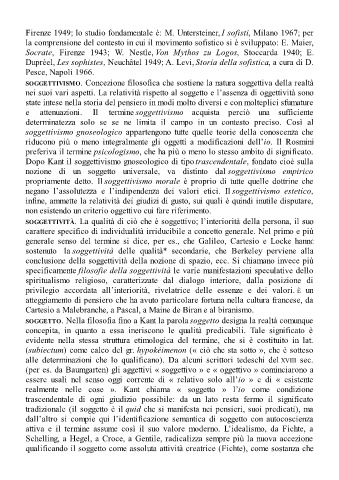Page 789 - Dizionario di Filosofia
P. 789
Firenze 1949; lo studio fondamentale è: M. Untersteiner, I sofisti, Milano 1967; per
la comprensione del contesto in cui il movimento sofistico si è sviluppato: E. Maier,
Socrate, Firenze 1943; W. Nestle, Von Mythos zu Logos, Stoccarda 1940; E.
Dupréel, Les sophistes, Neuchâtel 1949; A. Levi, Storia della sofistica, a cura di D.
Pesce, Napoli 1966.
SOGGETTIVISMO. Concezione filosofica che sostiene la natura soggettiva della realtà
nei suoi vari aspetti. La relatività rispetto al soggetto e l’assenza di oggettività sono
state intese nella storia del pensiero in modi molto diversi e con molteplici sfumature
e attenuazioni. Il termine soggettivismo acquista perciò una sufficiente
determinatezza solo se se ne limita il campo in un contesto preciso. Così al
soggettivismo gnoseologico appartengono tutte quelle teorie della conoscenza che
riducono più o meno integralmente gli oggetti a modificazioni dell’io. Il Rosmini
preferiva il termine psicologismo, che ha più o meno lo stesso ambito di significato.
Dopo Kant il soggettivismo gnoseologico di tipo trascendentale, fondato cioè sulla
nozione di un soggetto universale, va distinto dal soggettivismo empirico
propriamente detto. Il soggettivismo morale è proprio di tutte quelle dottrine che
negano l’assolutezza e l’indipendenza dei valori etici. Il soggettivismo estetico,
infine, ammette la relatività dei giudizi di gusto, sui quali è quindi inutile disputare,
non esistendo un criterio oggettivo cui fare riferimento.
SOGGETTIVITÀ. La qualità di ciò che è soggettivo; l’interiorità della persona, il suo
carattere specifico di individualità irriducibile a concetto generale. Nel primo e più
generale senso del termine si dice, per es., che Galileo, Cartesio e Locke hanno
sostenuto la soggettività delle qualità* secondarie, che Berkeley perviene alla
conclusione della soggettività della nozione di spazio, ecc. Si chiamano invece più
specificamente filosofie della soggettività le varie manifestazioni speculative dello
spiritualismo religioso, caratterizzate dal dialogo interiore, dalla posizione di
privilegio accordata all’interiorità, rivelatrice delle essenze e dei valori. È un
atteggiamento di pensiero che ha avuto particolare fortuna nella cultura francese, da
Cartesio a Malebranche, a Pascal, a Maine de Biran e al biranismo.
SOGGETTO. Nella filosofia fino a Kant la parola soggetto designa la realtà comunque
concepita, in quanto a essa ineriscono le qualità predicabili. Tale significato è
evidente nella stessa struttura etimologica del termine, che si è costituito in lat.
(subiectum) come calco del gr. hypokéimenon (« ciò che sta sotto », che è sotteso
alle determinazioni che lo qualificano). Da alcuni scrittori tedeschi del XVIII sec.
(per es. da Baumgarten) gli aggettivi « soggettivo » e « oggettivo » cominciarono a
essere usali nel senso oggi corrente di « relativo solo all’io » e di « esistente
realmente nelle cose ». Kant chiama « soggetto » l’io come condizione
trascendentale di ogni giudizio possibile: da un lato resta fermo il significato
tradizionale (il soggetto è il quid che si manifesta nei pensieri, suoi predicati), ma
dall’altro si compie qui l’identificazione semantica di soggetto con autocoscienza
attiva e il termine assume così il suo valore moderno. L’idealismo, da Fichte, a
Schelling, a Hegel, a Croce, a Gentile, radicalizza sempre più la nuova accezione,
qualificando il soggetto come assoluta attività creatrice (Fichte), come sostanza che