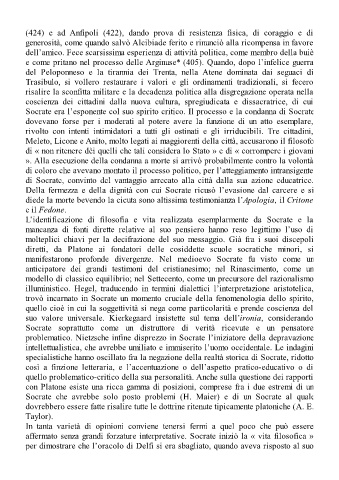Page 786 - Dizionario di Filosofia
P. 786
(424) e ad Anfipoli (422), dando prova di resistenza fisica, di coraggio e di
generosità, come quando salvò Alcibiade ferito e rinunciò alla ricompensa in favore
dell’amico. Fece scarsissima esperienza di attività politica, come membro della buiè
e come pritano nel processo delle Arginuse* (405). Quando, dopo l’infelice guerra
del Peloponneso e la tirannia dei Trenta, nella Atene dominata dai seguaci di
Trasibulo, si vollero restaurare i valori e gli ordinamenti tradizionali, si fecero
risalire la sconfitta militare e la decadenza politica alla disgregazione operata nella
coscienza dei cittadini dalla nuova cultura, spregiudicata e dissacratrice, di cui
Socrate era l’esponente col suo spirito critico. Il processo e la condanna di Socrate
dovevano forse per i moderati al potere avere la funzione di un atto esemplare,
rivolto con intenti intimidatori a tutti gli ostinati e gli irriducibili. Tre cittadini,
Meleto, Licone e Anito, molto legati ai maggiorenti della città, accusarono il filosofo
di « non ritenere dèi quelli che tali considera lo Stato » e di « corrompere i giovani
». Alla esecuzione della condanna a morte si arrivò probabilmente contro la volontà
di coloro che avevano montato il processo politico, per l’atteggiamento intransigente
di Socrate, convinto del vantaggio arrecato alla città dalla sua azione educatrice.
Della fermezza e della dignità con cui Socrate ricusò l’evasione dal carcere e si
diede la morte bevendo la cicuta sono altissima testimonianza l’Apologia, il Critone
e il Fedone.
L’identificazione di filosofia e vita realizzata esemplarmente da Socrate e la
mancanza di fonti dirette relative al suo pensiero hanno reso legittimo l’uso di
molteplici chiavi per la decifrazione del suo messaggio. Già fra i suoi discepoli
diretti, da Platone ai fondatori delle cosiddette scuole socratiche minori, si
manifestarono profonde divergenze. Nel medioevo Socrate fu visto come un
anticipatore dei grandi testimoni del cristianesimo; nel Rinascimento, come un
modello di classico equilibrio; nel Settecento, come un precursore del razionalismo
illuministico. Hegel, traducendo in termini dialettici l’interpretazione aristotelica,
trovò incarnato in Socrate un momento cruciale della fenomenologia dello spirito,
quello cioè in cui la soggettività si nega come particolarità e prende coscienza del
suo valore universale. Kierkegaard insistette sul tema dell’ironia, considerando
Socrate soprattutto come un distruttore di verità ricevute e un pensatore
problematico. Nietzsche infine disprezzo in Socrate l’iniziatore della depravazione
intellettualistica, che avrebbe umiliato e immiserito l’uomo occidentale. Le indagini
specialistiche hanno oscillato fra la negazione della realtà storica di Socrate, ridotto
così a finzione letteraria, e l’accentuazione o dell’aspetto pratico-educativo o di
quello problematico-critico della sua personalità. Anche sulla questione dei rapporti
con Platone esiste una ricca gamma di posizioni, comprese fra i due estremi di un
Socrate che avrebbe solo posto problemi (H. Maier) e di un Socrate al quale
dovrebbero essere fatte risalire tutte le dottrine ritenute tipicamente platoniche (A. E.
Taylor).
In tanta varietà di opinioni conviene tenersi fermi a quel poco che può essere
affermato senza grandi forzature interpretative. Socrate iniziò la « vita filosofica »
per dimostrare che l’oracolo di Delfi si era sbagliato, quando aveva risposto al suo