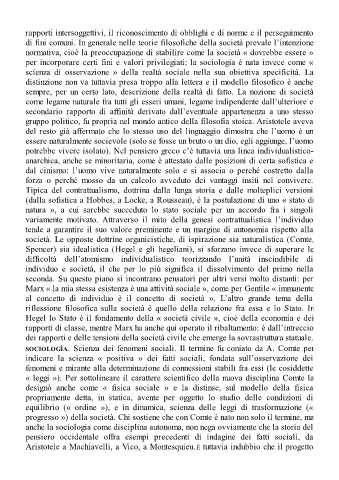Page 781 - Dizionario di Filosofia
P. 781
rapporti intersoggettivi, il riconoscimento di obblighi e di norme e il perseguimento
di fini comuni. In generale nelle teorie filosofiche della società prevale l’intenzione
normativa, cioè la preoccupazione di stabilire come la società « dovrebbe essere »
per incorporare certi fini e valori privilegiati; la sociologia è nata invece come «
scienza di osservazione » della realtà sociale nella sua obiettiva specificità. La
distinzione non va tuttavia presa troppo alla lettera e il modello filosofico è anche
sempre, per un certo lato, descrizione della realtà di fatto. La nozione di società
come legame naturale fra tutti gli esseri umani, legame indipendente dall’ulteriore e
secondario rapporto di affinità derivato dall’eventuale appartenenza a uno stesso
gruppo politico, fu propria nel mondo antico della filosofia stoica. Aristotele aveva
del resto già affermato che lo stesso uso del linguaggio dimostra che l’uomo è un
essere naturalmente socievole (solo se fosse un bruto o un dio, egli aggiunge, l’uomo
potrebbe vivere isolato). Nel pensiero greco c’è tuttavia una linea individualistico-
anarchica, anche se minoritaria, come è attestato dalle posizioni di certa sofistica e
dal cinismo: l’uomo vive naturalmente solo e si associa o perché costretto dalla
forza o perché mosso da un calcolo avveduto dei vantaggi insiti nel convivere.
Tipica del contrattualismo, dottrina dalla lunga storia e dalle molteplici versioni
(dalla sofistica a Hobbes, a Locke, a Rousseau), è la postulazione di uno « stato di
natura », a cui sarebbe succeduto lo stato sociale per un accordo fra i singoli
variamente motivato. Attraverso il mito della genesi contrattualistica l’individuo
tende a garantire il suo valore preminente e un margine di autonomia rispetto alla
società. Le opposte dottrine organicistiche, di ispirazione sia naturalistica (Comte,
Spencer) sia idealistica (Hegel e gli hegeliani), si sforzano invece di superare le
difficoltà dell’atomismo individualistico teorizzando l’unità inscindibile di
individuo e società, il che per lo più significa il dissolvimento del primo nella
seconda. Su questo piano si incontrano pensatori per altri versi molto distanti: per
Marx « la mia stessa esistenza è una attività sociale », come per Gentile « immanente
al concetto di individuo è il concetto di società ». L’altro grande tema della
riflessione filosofica sulla società è quello della relazione fra essa e lo Stato. In
Hegel lo Stato è il fondamento della « società civile », cioè della economia e dei
rapporti di classe, mentre Marx ha anche qui operato il ribaltamento: è dall’intreccio
dei rapporti e delle tensioni della società civile che emerge la sovrastruttura statuale.
SOCIOLOGÌA. Scienza dei fenomeni sociali. Il termine fu coniato da A. Comte per
indicare la scienza « positiva » dei fatti sociali, fondata sull’osservazione dei
fenomeni e mirante alla determinazione di connessioni stabili fra essi (le cosiddette
« leggi »). Per sottolineare il carattere scientifico della nuova disciplina Comte la
designò anche come « fisica sociale » e la distinse, sul modello della fisica
propriamente detta, in statica, avente per oggetto lo studio delle condizioni di
equilibrio (« ordine »), e in dinamica, scienza delle leggi di trasformazione («
progresso ») della società. Chi sostiene che con Comte è nato non solo il termine, ma
anche la sociologia come disciplina autonoma, non nega ovviamente che la storia del
pensiero occidentale offra esempi precedenti di indagine dei fatti sociali, da
Aristotele a Machiavelli, a Vico, a Montesquieu. È tuttavia indubbio che il progetto