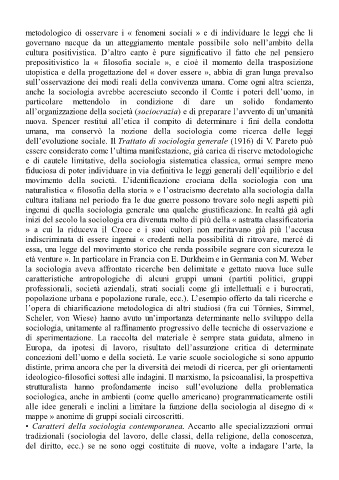Page 782 - Dizionario di Filosofia
P. 782
metodologico di osservare i « fenomeni sociali » e di individuare le leggi che li
governano nacque da un atteggiamento mentale possibile solo nell’ambito della
cultura positivistica. D’altro canto è pure significativo il fatto che nel pensiero
prepositivistico la « filosofia sociale », e cioè il momento della trasposizione
utopistica e della progettazione del « dover essere », abbia di gran lunga prevalso
sull’osservazione dei modi reali della convivenza umana. Come ogni altra scienza,
anche la sociologia avrebbe accresciuto secondo il Comte i poteri dell’uomo, in
particolare mettendolo in condizione di dare un solido fondamento
all’organizzazione della società (sociocrazia) e di preparare l’avvento di un’umanità
nuova. Spencer restituì all’etica il compito di determinare i fini della condotta
umana, ma conservò la nozione della sociologia come ricerca delle leggi
dell’evoluzione sociale. Il Trattato di sociologia generale (1916) di V. Pareto può
essere considerato come l’ultima manifestazione, già carica di riserve metodologiche
e di cautele limitative, della sociologia sistematica classica, ormai sempre meno
fiduciosa di poter individuare in via definitiva le leggi generali dell’equilibrio e del
movimento della società. L’identificazione crociana della sociologia con una
naturalistica « filosofia della storia » e l’ostracismo decretato alla sociologia dalla
cultura italiana nel periodo fra le due guerre possono trovare solo negli aspetti più
ingenui di quella sociologia generale una qualche giustificazione. In realtà già agli
inizi del secolo la sociologia era divenuta molto di più della « astratta classificatoria
» a cui la riduceva il Croce e i suoi cultori non meritavano già più l’accusa
indiscriminata di essere ingenui « credenti nella possibilità di ritrovare, mercé di
essa, una legge del movimento storico che renda possibile segnare con sicurezza le
età venture ». In particolare in Francia con E. Durkheim e in Germania con M. Weber
la sociologia aveva affrontato ricerche ben delimitate e gettato nuova luce sulle
caratteristiche antropologiche di alcuni gruppi umani (partiti politici, gruppi
professionali, società aziendali, strati sociali come gli intellettuali e i burocrati,
popolazione urbana e popolazione rurale, ecc.). L’esempio offerto da tali ricerche e
l’opera di chiarificazione metodologica di altri studiosi (fra cui Tönnies, Simmel,
Scheler, von Wiese) hanno avuto un’importanza determinante nello sviluppo della
sociologia, unitamente al raffinamento progressivo delle tecniche di osservazione e
di sperimentazione. La raccolta del materiale è sempre stata guidata, almeno in
Europa, da ipotesi di lavoro, risultato dell’assunzione critica di determinate
concezioni dell’uomo e della società. Le varie scuole sociologiche si sono appunto
distinte, prima ancora che per la diversità dei metodi di ricerca, per gli orientamenti
ideologico-filosofici sottesi alle indagini. Il marxismo, la psicoanalisi, la prospettiva
strutturalista hanno profondamente inciso sull’evoluzione della problematica
sociologica, anche in ambienti (come quello americano) programmaticamente ostili
alle idee generali e inclini a limitare la funzione della sociologia al disegno di «
mappe » anonime di gruppi sociali circoscritti.
• Caratteri della sociologia contemporanea. Accanto alle specializzazioni ormai
tradizionali (sociologia del lavoro, delle classi, della religione, della conoscenza,
del diritto, ecc.) se ne sono oggi costituite di nuove, volte a indagare l’arte, la