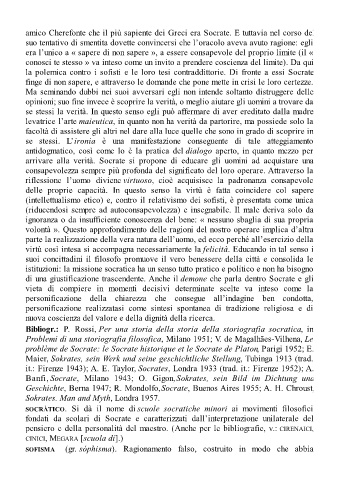Page 787 - Dizionario di Filosofia
P. 787
amico Cherefonte che il più sapiente dei Greci era Socrate. E tuttavia nel corso del
suo tentativo di smentita dovette convincersi che l’oracolo aveva avuto ragione: egli
era l’unico a « sapere di non sapere », a essere consapevole del proprio limite (il «
conosci te stesso » va inteso come un invito a prendere coscienza del limite). Da qui
la polemica contro i sofisti e le loro tesi contraddittorie. Di fronte a essi Socrate
finge di non sapere, e attraverso le domande che pone mette in crisi le loro certezze.
Ma seminando dubbi nei suoi avversari egli non intende soltanto distruggere delle
opinioni; suo fine invece è scoprire la verità, o meglio aiutare gli uomini a trovare da
se stessi la verità. In questo senso egli può affermare di aver ereditato dalla madre
levatrice l’arte maieutica, in quanto non ha verità da partorire, ma possiede solo la
facoltà di assistere gli altri nel dare alla luce quelle che sono in grado di scoprire in
se stessi. L’ironia è una manifestazione conseguente di tale atteggiamento
antidogmatico, così come lo è la pratica del dialogo aperto, in quanto mezzo per
arrivare alla verità. Socrate si propone di educare gli uomini ad acquistare una
consapevolezza sempre più profonda del significato del loro operare. Attraverso la
riflessione l’uomo diviene virtuoso, cioè acquisisce la padronanza consapevole
delle proprie capacità. In questo senso la virtù è fatta coincidere col sapere
(intellettualismo etico) e, contro il relativismo dei sofisti, è presentata come unica
(riducendosi sempre ad autoconsapevolezza) e insegnabile. Il male deriva solo da
ignoranza o da insufficiente conoscenza del bene: « nessuno sbaglia di sua propria
volontà ». Questo approfondimento delle ragioni del nostro operare implica d’altra
parte la realizzazione della vera natura dell’uomo, ed ecco perché all’esercizio della
virtù così intesa si accompagna necessariamente la felicità. Educando in tal senso i
suoi concittadini il filosofo promuove il vero benessere della città e consolida le
istituzioni: la missione socratica ha un senso tutto pratico e politico e non ha bisogno
di una giustificazione trascendente. Anche il demone che parla dentro Socrate e gli
vieta di compiere in momenti decisivi determinate scelte va inteso come la
personificazione della chiarezza che consegue all’indagine ben condotta,
personificazione realizzatasi come sintesi spontanea di tradizione religiosa e di
nuova coscienza del valore e della dignità della ricerca.
Bibliogr.: P. Rossi, Per una storia della storia della storiografia socratica, in
Problemi di una storiografia filosofica, Milano 1951; V. de Magalhães-Vilhena, Le
problème de Socrate: le Socrate historique et le Socrate de Platon, Parigi 1952; E.
Maier, Sokrates, sein Werk und seine geschichtliche Stellung, Tubinga 1913 (trad.
it.: Firenze 1943); A. E. Taylor, Socrates, Londra 1933 (trad. it.: Firenze 1952); A.
Banfi, Socrate, Milano 1943; O. Gigon, Sokrates, sein Bild im Dichtung und
Geschichte, Berna 1947; R. Mondolfo, Socrate, Buenos Aires 1955; A. H. Chroust,
Sokrates. Man and Myth, Londra 1957.
SOCRÀTICO. Si dà il nome di scuole socratiche minori ai movimenti filosofici
fondati da scolari di Socrate e caratterizzati dall’interpretazione unilaterale del
pensiero e della personalità del maestro. (Anche per le bibliografie, v.: CIRENAICI,
CINICI, MEGARA [scuola di].)
SOFISMA (gr. sóphisma). Ragionamento falso, costruito in modo che abbia