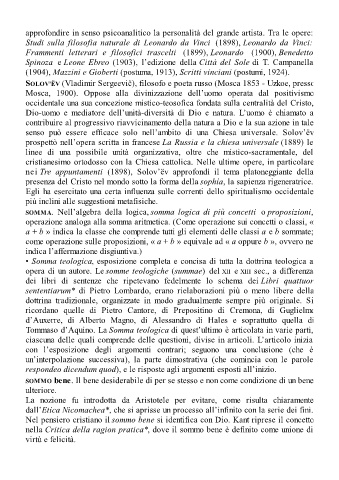Page 791 - Dizionario di Filosofia
P. 791
approfondire in senso psicoanalitico la personalità del grande artista. Tra le opere:
Studi sulla filosofia naturale di Leonardo da Vinci (1898), Leonardo da Vinci:
Frammenti letterari e filosofici trascelti (1899), Leonardo (1900), Benedetto
Spinoza e Leone Ebreo (1903), l’edizione della Città del Sole di T. Campanella
(1904), Mazzini e Gioberti (postuma, 1913), Scritti vinciani (postumi, 1924).
SOLOV’ËV (Vladimir Sergeevič), filosofo e poeta russo (Mosca 1853 - Uzkoe, presso
Mosca, 1900). Oppose alla divinizzazione dell’uomo operata dal positivismo
occidentale una sua concezione mistico-teosofica fondata sulla centralità del Cristo,
Dio-uomo e mediatore dell’unità-diversità di Dio e natura. L’uomo è chiamato a
contribuire al progressivo riavvicinamento della natura a Dio e la sua azione in tale
senso può essere efficace solo nell’ambito di una Chiesa universale. Solov’ëv
prospettò nell’opera scritta in francese La Russia e la chiesa universale (1889) le
linee di una possibile unità organizzativa, oltre che mistico-sacramentale, del
cristianesimo ortodosso con la Chiesa cattolica. Nelle ultime opere, in particolare
nei Tre appuntamenti (1898), Solov’ëv approfondì il tema platoneggiante della
presenza del Cristo nel mondo sotto la forma della sophía, la sapienza rigeneratrice.
Egli ha esercitato una certa influenza sulle correnti dello spiritualismo occidentale
più inclini alle suggestioni metafisiche.
SOMMA. Nell’algebra della logica, somma logica di più concetti o proposizioni,
operazione analoga alla somma aritmetica. (Come operazione sui concetti o classi, «
a + b » indica la classe che comprende tutti gli elementi delle classi a e b sommate;
come operazione sulle proposizioni, « a + b » equivale ad « a oppure b », ovvero ne
indica l’affermazione disgiuntiva.)
• Somma teologica, esposizione completa e concisa di tutta la dottrina teologica a
opera di un autore. Le somme teologiche (summae) del XII e XIII sec., a differenza
dei libri di sentenze che ripetevano fedelmente lo schema dei Libri quattuor
sententiarum* di Pietro Lombardo, erano rielaborazioni più o meno libere della
dottrina tradizionale, organizzate in modo gradualmente sempre più originale. Si
ricordano quelle di Pietro Cantore, di Prepositino di Cremona, di Guglielmo
d’Auxerre, di Alberto Magno, di Alessandro di Hales e soprattutto quella di
Tommaso d’Aquino. La Somma teologica di quest’ultimo è articolata in varie parti,
ciascuna delle quali comprende delle questioni, divise in articoli. L’articolo inizia
con l’esposizione degli argomenti contrari; seguono una conclusione (che è
un’interpolazione successiva), la parte dimostrativa (che comincia con le parole
respondeo dicendum quod), e le risposte agli argomenti esposti all’inizio.
SOMMO bene. Il bene desiderabile di per se stesso e non come condizione di un bene
ulteriore.
La nozione fu introdotta da Aristotele per evitare, come risulta chiaramente
dall’Etica Nicomachea*, che si aprisse un processo all’infinito con la serie dei fini.
Nel pensiero cristiano il sommo bene si identifica con Dio. Kant riprese il concetto
nella Critica della ragion pratica*, dove il sommo bene è definito come unione di
virtù e felicità.