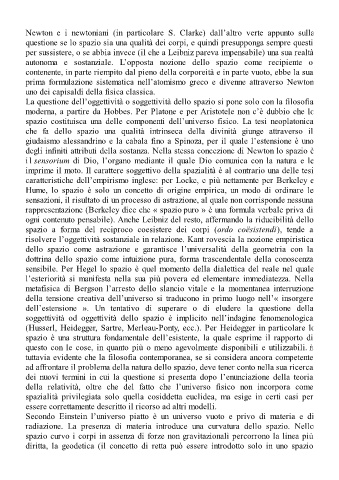Page 796 - Dizionario di Filosofia
P. 796
Newton e i newtoniani (in particolare S. Clarke) dall’altro verte appunto sulla
questione se lo spazio sia una qualità dei corpi, e quindi presupponga sempre questi
per sussistere, o se abbia invece (il che a Leibniz pareva impensabile) una sua realtà
autonoma e sostanziale. L’opposta nozione dello spazio come recipiente o
contenente, in parte riempito dal pieno della corporeità e in parte vuoto, ebbe la sua
prima formulazione sistematica nell’atomismo greco e divenne attraverso Newton
uno dei capisaldi della fìsica classica.
La questione dell’oggettività o soggettività dello spazio si pone solo con la filosofia
moderna, a partire da Hobbes. Per Platone e per Aristotele non c’è dubbio che lo
spazio costituisca una delle componenti dell’universo fisico. La tesi neoplatonica
che fa dello spazio una qualità intrinseca della divinità giunge attraverso il
giudaismo alessandrino e la cabala fino a Spinoza, per il quale l’estensione è uno
degli infiniti attributi della sostanza. Nella stessa concezione di Newton lo spazio è
i l sensorium di Dio, l’organo mediante il quale Dio comunica con la natura e le
imprime il moto. Il carattere soggettivo della spazialità è al contrario una delle tesi
caratteristiche dell’empirismo inglese: per Locke, e più nettamente per Berkeley e
Hume, lo spazio è solo un concetto di origine empirica, un modo di ordinare le
sensazioni, il risultato di un processo di astrazione, al quale non corrisponde nessuna
rappresentazione (Berkeley dice che « spazio puro » è una formula verbale priva di
ogni contenuto pensabile). Anche Leibniz del resto, affermando la riducibilità dello
spazio a forma del reciproco coesistere dei corpi (ordo coësistendi), tende a
risolvere l’oggettività sostanziale in relazione. Kant rovescia la nozione empiristica
dello spazio come astrazione e garantisce l’universalità della geometria con la
dottrina dello spazio come intuizione pura, forma trascendentale della conoscenza
sensibile. Per Hegel lo spazio è quel momento della dialettica del reale nel quale
l’esteriorità si manifesta nella sua più povera ed elementare immediatezza. Nella
metafisica di Bergson l’arresto dello slancio vitale e la momentanea interruzione
della tensione creativa dell’universo si traducono in primo luogo nell’« insorgere
dell’estensione ». Un tentativo di superare o di eludere la questione della
soggettività od oggettività dello spazio è implicito nell’indagine fenomenologica
(Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, ecc.). Per Heidegger in particolare lo
spazio è una struttura fondamentale dell’esistente, la quale esprime il rapporto di
questo con le cose, in quanto più o meno agevolmente disponibili e utilizzabili. È
tuttavia evidente che la filosofia contemporanea, se si considera ancora competente
ad affrontare il problema della natura dello spazio, deve tener conto nella sua ricerca
dei nuovi termini in cui la questione si presenta dopo l’enunciazione della teoria
della relatività, oltre che del fatto che l’universo fisico non incorpora come
spazialità privilegiata solo quella cosiddetta euclidea, ma esige in certi casi per
essere correttamente descritto il ricorso ad altri modelli.
Secondo Einstein l’universo piatto è un universo vuoto e privo di materia e di
radiazione. La presenza di materia introduce una curvatura dello spazio. Nello
spazio curvo i corpi in assenza di forze non gravitazionali percorrono la linea più
diritta, la geodetica (il concetto di retta può essere introdotto solo in uno spazio