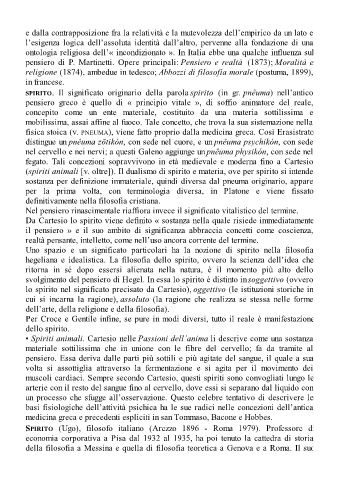Page 804 - Dizionario di Filosofia
P. 804
e dalla contrapposizione fra la relatività e la mutevolezza dell’empirico da un lato e
l’esigenza logica dell’assoluta identità dall’altro, pervenne alla fondazione di una
ontologia religiosa dell’« incondizionato ». In Italia ebbe una qualche influenza sul
pensiero di P. Martinetti. Opere principali: Pensiero e realtà (1873); Moralità e
religione (1874), ambedue in tedesco; Abbozzi di filosofia morale (postuma, 1899),
in francese.
SPIRITO. Il significato originario della parola spirito (in gr. pnêuma) nell’antico
pensiero greco è quello di « principio vitale », di soffio animatore del reale,
concepito come un ente materiale, costituito da una materia sottilissima e
mobilissima, assai affine al fuoco. Tale concetto, che trova la sua sistemazione nella
fisica stoica (v. PNEUMA), viene fatto proprio dalla medicina greca. Così Erasistrato
distingue un pnêuma zōtikón, con sede nel cuore, e un pnêuma psychikón, con sede
nel cervello e nei nervi; a questi Galeno aggiunge un pnêuma physikón, con sede nel
fegato. Tali concezioni sopravvivono in età medievale e moderna fino a Cartesio
(spiriti animali [v. oltre]). Il dualismo di spirito e materia, ove per spirito si intende
sostanza per definizione immateriale, quindi diversa dal pneuma originario, appare
per la prima volta, con terminologia diversa, in Platone e viene fissato
definitivamente nella filosofia cristiana.
Nel pensiero rinascimentale riaffiora invece il significato vitalistico del termine.
Da Cartesio lo spirito viene definito « sostanza nella quale risiede immediatamente
il pensiero » e il suo ambito di significanza abbraccia concetti come coscienza,
realtà pensante, intelletto, come nell’uso ancora corrente del termine.
Uno spazio e un significato particolari ha la nozione di spirito nella filosofia
hegeliana e idealistica. La filosofia dello spirito, ovvero la scienza dell’idea che
ritorna in sé dopo essersi alienata nella natura, è il momento più alto dello
svolgimento del pensiero di Hegel. In essa lo spirito è distinto in soggettivo (ovvero
lo spirito nel significato precisato da Cartesio), oggettivo (le istituzioni storiche in
cui si incarna la ragione), assoluto (la ragione che realizza se stessa nelle forme
dell’arte, della religione e della filosofia).
Per Croce e Gentile infine, se pure in modi diversi, tutto il reale è manifestazione
dello spirito.
• Spiriti animali. Cartesio nelle Passioni dell’anima li descrive come una sostanza
materiale sottilissima che in unione con le fibre del cervello; fa da tramite al
pensiero. Essa deriva dalle parti più sottili e più agitate del sangue, il quale a sua
volta si assottiglia attraverso la fermentazione e si agita per il movimento dei
muscoli cardiaci. Sempre secondo Cartesio, questi spiriti sono convogliati lungo le
arterie con il resto del sangue fino al cervello, dove essi si separano dal liquido con
un processo che sfugge all’osservazione. Questo celebre tentativo di descrivere le
basi fisiologiche dell’attività psichica ha le sue radici nelle concezioni dell’antica
medicina greca e precedenti espliciti in san Tommaso, Bacone e Hobbes.
SPIRITO (Ugo), filosofo italiano (Arezzo 1896 - Roma 1979). Professore di
economia corporativa a Pisa dal 1932 al 1935, ha poi tenuto la cattedra di storia
della filosofia a Messina e quella di filosofia teoretica a Genova e a Roma. Il suo