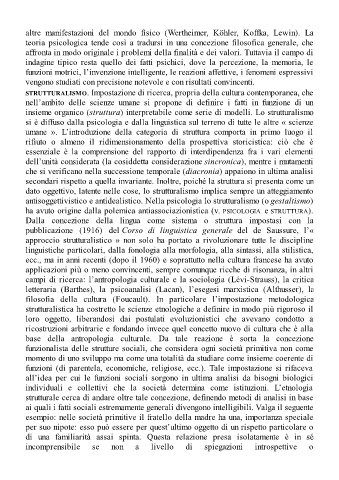Page 814 - Dizionario di Filosofia
P. 814
altre manifestazioni del mondo fìsico (Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin). La
teoria psicologica tende così a tradursi in una concezione filosofica generale, che
affronta in modo originale i problemi della finalità e dei valori. Tuttavia il campo di
indagine tipico resta quello dei fatti psichici, dove la percezione, la memoria, le
funzioni motrici, l’invenzione intelligente, le reazioni affettive, i fenomeni espressivi
vengono studiati con precisione notevole e con risultati convincenti.
STRUTTURALISMO. Impostazione di ricerca, propria della cultura contemporanea, che
nell’ambito delle scienze umane si propone di definire i fatti in funzione di un
insieme organico (struttura) interpretabile come serie di modelli. Lo strutturalismo
si è diffuso dalla psicologia e dalla linguistica sul terreno di tutte le altre « scienze
umane ». L’introduzione della categoria di struttura comporta in primo luogo il
rifiuto o almeno il ridimensionamento della prospettiva storicistica: ciò che è
essenziale è la comprensione del rapporto di interdipendenza fra i vari elementi
dell’unità considerata (la cosiddetta considerazione sincronica), mentre i mutamenti
che si verificano nella successione temporale (diacronia) appaiono in ultima analisi
secondari rispetto a quella invariante. Inoltre, poiché la struttura si presenta come un
dato oggettivo, latente nelle cose, lo strutturalismo implica sempre un atteggiamento
antisoggettivistico e antidealistico. Nella psicologia lo strutturalismo (o gestaltismo)
ha avuto origine dalla polemica antiassociazionistica (v. PSICOLOGIA e STRUTTURA).
Dalla concezione della lingua come sistema o struttura impostasi con la
pubblicazione (1916) del Corso di linguistica generale del de Saussure, l’«
approccio strutturalistico » non solo ha portato a rivoluzionare tutte le discipline
linguistiche particolari, dalla fonologia alla morfologia, alla sintassi, alla stilistica,
ecc., ma in anni recenti (dopo il 1960) e soprattutto nella cultura francese ha avuto
applicazioni più o meno convincenti, sempre comunque ricche di risonanza, in altri
campi di ricerca: l’antropologia culturale e la sociologia (Lévi-Strauss), la critica
letteraria (Barthes), la psicoanalisi (Lacan), l’esegesi marxistica (Althusser), la
filosofia della cultura (Foucault). In particolare l’impostazione metodologica
strutturalistica ha costretto le scienze etnologiche a definire in modo più rigoroso il
loro oggetto, liberandosi dai postulati evoluzionistici che avevano condotto a
ricostruzioni arbitrarie e fondando invece quel concetto nuovo di cultura che è alla
base della antropologia culturale. Da tale reazione è sorta la concezione
funzionalista delle strutture sociali, che considera ogni società primitiva non come
momento di uno sviluppo ma come una totalità da studiare come insieme coerente di
funzioni (di parentela, economiche, religiose, ecc.). Tale impostazione si rifaceva
all’idea per cui le funzioni sociali sorgono in ultima analisi da bisogni biologici
individuali e collettivi che la società determina come istituzioni. L’etnologia
strutturale cerca di andare oltre tale concezione, definendo metodi di analisi in base
ai quali i fatti sociali estremamente generali divengono intelligibili. Valga il seguente
esempio: nelle società primitive il fratello della madre ha una, importanza speciale
per suo nipote: esso può essere per quest’ultimo oggetto di un rispetto particolare o
di una familiarità assai spinta. Questa relazione presa isolatamente è in sé
incomprensibile se non a livello di spiegazioni introspettive o