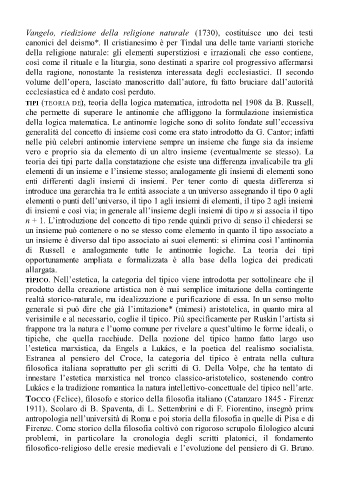Page 835 - Dizionario di Filosofia
P. 835
Vangelo, riedizione della religione naturale (1730), costituisce uno dei testi
canonici del deismo*. Il cristianesimo è per Tindal una delle tante varianti storiche
della religione naturale: gli elementi superstiziosi e irrazionali che esso contiene,
così come il rituale e la liturgia, sono destinati a sparire col progressivo affermarsi
della ragione, nonostante la resistenza interessata degli ecclesiastici. Il secondo
volume dell’opera, lasciato manoscritto dall’autore, fu fatto bruciare dall’autorità
ecclesiastica ed è andato così perduto.
TIPI (TEORIA DEI), teoria della logica matematica, introdotta nel 1908 da B. Russell,
che permette di superare le antinomie che affliggono la formulazione insiemistica
della logica matematica. Le antinomie logiche sono di solito fondate sull’eccessiva
generalità del concetto di insieme così come era stato introdotto da G. Cantor; infatti
nelle più celebri antinomie interviene sempre un insieme che funge sia da insieme
vero e proprio sia da elemento di un altro insieme (eventualmente se stesso). La
teoria dei tipi parte dalla constatazione che esiste una differenza invalicabile tra gli
elementi di un insieme e l’insieme stesso; analogamente gli insiemi di elementi sono
enti differenti dagli insiemi di insiemi. Per tener conto di questa differenza si
introduce una gerarchia tra le entità associate a un universo assegnando il tipo 0 agli
elementi o punti dell’universo, il tipo 1 agli insiemi di elementi, il tipo 2 agli insiemi
di insiemi e così via; in generale all’insieme degli insiemi di tipo n si associa il tipo
n + 1. L’introduzione del concetto di tipo rende quindi privo di senso il chiedersi se
un insieme può contenere o no se stesso come elemento in quanto il tipo associato a
un insieme è diverso dal tipo associato ai suoi elementi: si elimina così l’antinomia
di Russell e analogamente tutte le antinomie logiche. La teoria dei tipi
opportunamente ampliata e formalizzata è alla base della logica dei predicati
allargata.
TÌPICO. Nell’estetica, la categoria del tipico viene introdotta per sottolineare che il
prodotto della creazione artistica non è mai semplice imitazione della contingente
realtà storico-naturale, ma idealizzazione e purificazione di essa. In un senso molto
generale si può dire che già l’imitazione* (mimesi) aristotelica, in quanto mira al
verisimile e al necessario, coglie il tipico. Più specificamente per Ruskin l’artista si
frappone tra la natura e l’uomo comune per rivelare a quest’ultimo le forme ideali, o
tipiche, che quella racchiude. Della nozione del tipico hanno fatto largo uso
l’estetica marxistica, da Engels a Lukács, e la poetica del realismo socialista.
Estranea al pensiero del Croce, la categoria del tipico è entrata nella cultura
filosofica italiana soprattutto per gli scritti di G. Della Volpe, che ha tentato di
innestare l’estetica marxistica nel tronco classico-aristotelico, sostenendo contro
Lukács e la tradizione romantica la natura intellettivo-concettuale del tipico nell’arte.
TOCCO (Felice), filosofo e storico della filosofia italiano (Catanzaro 1845 - Firenze
1911). Scolaro di B. Spaventa, di L. Settembrini e di F. Fiorentino, insegnò prima
antropologia nell’università di Roma e poi storia della filosofia in quelle di Pisa e di
Firenze. Come storico della filosofia coltivò con rigoroso scrupolo filologico alcuni
problemi, in particolare la cronologia degli scritti platonici, il fondamento
filosofico-religioso delle eresie medievali e l’evoluzione del pensiero di G. Bruno.