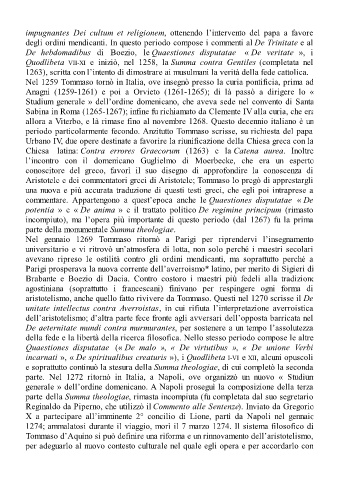Page 838 - Dizionario di Filosofia
P. 838
impugnantes Dei cultum et religionem, ottenendo l’intervento del papa a favore
degli ordini mendicanti. In questo periodo compose i commenti al De Trinitate e al
De hebdomadibus di Boezio, le Quaestiones disputatae « De veritate », i
Quodlibeta VII-XI e iniziò, nel 1258, la Summa contra Gentiles (completata nel
1263), scritta con l’intento di dimostrare ai musulmani la verità della fede cattolica.
Nel 1259 Tommaso tornò in Italia, ove insegnò presso la curia pontificia, prima ad
Anagni (1259-1261) e poi a Orvieto (1261-1265); di là passò a dirigere lo «
Studium generale » dell’ordine domenicano, che aveva sede nel convento di Santa
Sabina in Roma (1265-1267); infine fu richiamato da Clemente IV alla curia, che era
allora a Viterbo, e là rimase fino al novembre 1268. Questo decennio italiano è un
periodo particolarmente fecondo. Anzitutto Tommaso scrisse, su richiesta del papa
Urbano IV, due opere destinate a favorire la riunificazione della Chiesa greca con la
Chiesa latina: Contra errores Graecorum (1263) e la Catena aurea. Inoltre
l’incontro con il domenicano Guglielmo di Moerbecke, che era un esperto
conoscitore del greco, favorì il suo disegno di approfondire la conoscenza di
Aristotele e dei commentatori greci di Aristotele; Tommaso lo pregò di apprestargli
una nuova e più accurata traduzione di questi testi greci, che egli poi intraprese a
commentare. Appartengono a quest’epoca anche le Quaestiones disputatae « De
potentia » e « De anima » e il trattato politico De regimine principum (rimasto
incompiuto), ma l’opera più importante di questo periodo (dal 1267) fu la prima
parte della monumentale Summa theologiae.
Nel gennaio 1269 Tommaso ritornò a Parigi per riprendervi l’insegnamento
universitario e vi ritrovò un’atmosfera di lotta, non solo perché i maestri secolari
avevano ripreso le ostilità contro gli ordini mendicanti, ma soprattutto perché a
Parigi prosperava la nuova corrente dell’averroismo* latino, per merito di Sigieri di
Brabante e Boezio di Dacia. Contro costoro i maestri più fedeli alla tradizione
agostiniana (soprattutto i francescani) finivano per respingere ogni forma di
aristotelismo, anche quello fatto rivivere da Tommaso. Questi nel 1270 scrisse il De
unitate intellectus contra Averroistas, in cui rifiuta l’interpretazione averroistica
dell’aristotelismo; d’altra parte fece fronte agli avversari dell’opposta barricata nel
De aeternitate mundi contra murmurantes, per sostenere a un tempo l’assolutezza
della fede e la libertà della ricerca filosofica. Nello stesso periodo compose le altre
Quaestiones disputatae (« De malo », « De virtutibus », « De unione Verbi
incarnati », « De spiritualibus creaturis »), i Quodlibeta I-VI e XII, alcuni opuscoli
e soprattutto continuò la stesura della Summa theologiae, di cui completò la seconda
parte. Nel 1272 ritornò in Italia, a Napoli, ove organizzò un nuovo « Studium
generale » dell’ordine domenicano. A Napoli proseguì la composizione della terza
parte della Summa theologiae, rimasta incompiuta (fu completata dal suo segretario
Reginaldo da Piperno, che utilizzò il Commento alle Sentenze). Inviato da Gregorio
X a partecipare all’imminente 2° concilio di Lione, partì da Napoli nel gennaio
1274; ammalatosi durante il viaggio, morì il 7 marzo 1274. Il sistema filosofico di
Tommaso d’Aquino si può definire una riforma e un rinnovamento dell’aristotelismo,
per adeguarlo al nuovo contesto culturale nel quale egli opera e per accordarlo con