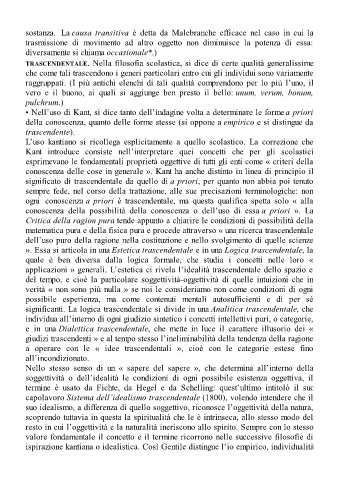Page 843 - Dizionario di Filosofia
P. 843
sostanza. La causa transitiva è detta da Malebranche efficace nel caso in cui la
trasmissione di movimento ad altro oggetto non diminuisce la potenza di essa:
diversamente si chiama occasionale*.)
TRASCENDENTALE. Nella filosofia scolastica, si dice di certe qualità generalissime
che come tali trascendono i generi particolari entro cui gli individui sono variamente
raggruppati. (I più antichi elenchi di tali qualità comprendono per lo più l’uno, il
vero e il buono, ai quali si aggiunge ben presto il bello: unum, verum, bonum,
pulchrum.)
• Nell’uso di Kant, si dice tanto dell’indagine volta a determinare le forme a priori
della conoscenza, quanto delle forme stesse (si oppone a empirico e si distingue da
trascendente).
L’uso kantiano si ricollega esplicitamente a quello scolastico. La correzione che
Kant introduce consiste nell’interpretare quei concetti che per gli scolastici
esprimevano le fondamentali proprietà oggettive di tutti gli enti come « criteri della
conoscenza delle cose in generale ». Kant ha anche distinto in linea di principio il
significato di trascendentale da quello di a priori, per quanto non abbia poi tenuto
sempre fede, nel corso della trattazione, alle sue precisazioni terminologiche: non
ogni conoscenza a priori è trascendentale, ma questa qualifica spetta solo « alla
conoscenza della possibilità della conoscenza o dell’uso di essa a priori ». La
Critica della ragion pura tende appunto a chiarire le condizioni di possibilità della
matematica pura e della fisica pura e procede attraverso « una ricerca trascendentale
dell’uso puro della ragione nella costituzione e nello svolgimento di quelle scienze
». Essa si articola in una Estetica trascendentale e in una Logica trascendentale, la
quale è ben diversa dalla logica formale, che studia i concetti nelle loro «
applicazioni » generali. L’estetica ci rivela l’idealità trascendentale dello spazio e
del tempo, e cioè la particolare soggettività-oggettività di quelle intuizioni che in
verità « non sono più nulla » se noi le consideriamo non come condizioni di ogni
possibile esperienza, ma come contenuti mentali autosufficienti e di per sé
significanti. La logica trascendentale si divide in una Analitica trascendentale, che
individua all’interno di ogni giudizio sintetico i concetti intellettivi puri, o categorie,
e in una Dialettica trascendentale, che mette in luce il carattere illusorio dei «
giudizi trascendenti » e al tempo stesso l’ineliminabilità della tendenza della ragione
a operare con le « idee trascendentali », cioè con le categorie estese fino
all’incondizionato.
Nello stesso senso di un « sapere del sapere », che determina all’interno della
soggettività o dell’idealità le condizioni di ogni possibile esistenza oggettiva, il
termine è usato da Fichte, da Hegel e da Schelling: quest’ultimo intitolò il suo
capolavoro Sistema dell’idealismo trascendentale (1800), volendo intendere che il
suo idealismo, a differenza di quello soggettivo, riconosce l’oggettività della natura,
scoprendo tuttavia in questa la spiritualità che le è intrinseca, allo stesso modo del
resto in cui l’oggettività e la naturalità ineriscono allo spirito. Sempre con lo stesso
valore fondamentale il concetto e il termine ricorrono nelle successive filosofie di
ispirazione kantiana o idealistica. Così Gentile distingue l’io empirico, individualità