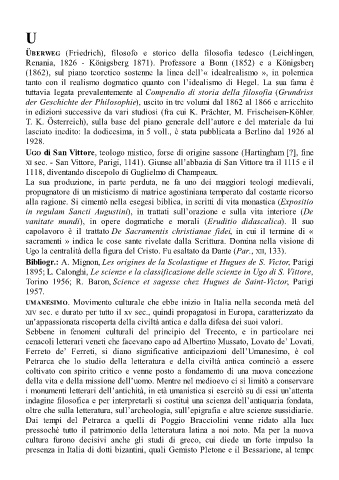Page 848 - Dizionario di Filosofia
P. 848
U
ÜBERWEG (Friedrich), filosofo e storico della filosofia tedesco (Leichlingen,
Renania, 1826 - Königsberg 1871). Professore a Bonn (1852) e a Königsberg
(1862), sul piano teoretico sostenne la linea dell’« idealrealismo », in polemica
tanto con il realismo dogmatico quanto con l’idealismo di Hegel. La sua fama è
tuttavia legata prevalentemente al Compendio di storia della filosofia (Grundriss
der Geschichte der Philosophie), uscito in tre volumi dal 1862 al 1866 e arricchito
in edizioni successive da vari studiosi (fra cui K. Prächter, M. Frischeisen-Köhler,
T. K. Österreich), sulla base del piano generale dell’autore e del materiale da lui
lasciato inedito: la dodicesima, in 5 voll., è stata pubblicata a Berlino dal 1926 al
1928.
UGO di San Vittore, teologo mistico, forse di origine sassone (Hartingham [?], fine
XI sec. - San Vittore, Parigi, 1141). Giunse all’abbazia di San Vittore tra il 1115 e il
1118, diventando discepolo di Guglielmo di Champeaux.
La sua produzione, in parte perduta, ne fa uno dei maggiori teologi medievali,
propugnatore di un misticismo di matrice agostiniana temperato dal costante ricorso
alla ragione. Si cimentò nella esegesi biblica, in scritti di vita monastica (Expositio
in regulam Sancti Augustini), in trattati sull’orazione e sulla vita interiore (De
vanitate mundi), in opere dogmatiche e morali (Eruditio didascalica). Il suo
capolavoro è il trattato De Sacramentis christianae fidei, in cui il termine di «
sacramenti » indica le cose sante rivelate dalla Scrittura. Domina nella visione di
Ugo la centralità della figura del Cristo. Fu esaltato da Dante (Par., XII, 133).
Bibliogr.: A. Mignon, Les origines de la Scolastique et Hugues de S. Victor, Parigi
1895; L. Calonghi, Le scienze e la classificazione delle scienze in Ugo di S. Vittore,
Torino 1956; R. Baron, Science et sagesse chez Hugues de Saint-Victor, Parigi
1957.
UMANESIMO. Movimento culturale che ebbe inizio in Italia nella seconda metà del
XIV sec. e durato per tutto il xv sec., quindi propagatosi in Europa, caratterizzato da
un’appassionata riscoperta della civiltà antica e dalla difesa dei suoi valori.
Sebbene in fenomeni culturali del principio del Trecento, e in particolare nei
cenacoli letterari veneti che facevano capo ad Albertino Mussato, Lovato de’ Lovati,
Ferreto de’ Ferreti, si diano significative anticipazioni dell’Umanesimo, è col
Petrarca che lo studio della letteratura e della civiltà antica cominciò a essere
coltivato con spirito critico e venne posto a fondamento di una nuova concezione
della vita e della missione dell’uomo. Mentre nel medioevo ci si limitò a conservare
i monumenti letterari dell’antichità, in età umanistica si esercitò su di essi un’attenta
indagine filosofica e per interpretarli si costituì una scienza dell’antiquaria fondata,
oltre che sulla letteratura, sull’archeologia, sull’epigrafia e altre scienze sussidiarie.
Dai tempi del Petrarca a quelli di Poggio Bracciolini venne ridato alla luce
pressoché tutto il patrimonio della letteratura latina a noi noto. Ma per la nuova
cultura furono decisivi anche gli studi di greco, cui diede un forte impulso la
presenza in Italia di dotti bizantini, quali Gemisto Pletone e il Bessarione, al tempo