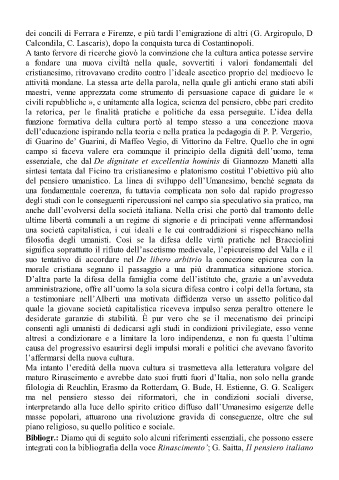Page 849 - Dizionario di Filosofia
P. 849
dei concili di Ferrara e Firenze, e più tardi l’emigrazione di altri (G. Argiropulo, D.
Calcondila, C. Lascaris), dopo la conquista turca di Costantinopoli.
A tanto fervore di ricerche giovò la convinzione che la cultura antica potesse servire
a fondare una nuova civiltà nella quale, sovvertiti i valori fondamentali del
cristianesimo, ritrovavano credito contro l’ideale ascetico proprio del medioevo le
attività mondane. La stessa arte della parola, nella quale gli antichi erano stati abili
maestri, venne apprezzata come strumento di persuasione capace di guidare le «
civili repubbliche », e unitamente alla logica, scienza del pensiero, ebbe pari credito
la retorica, per le finalità pratiche e politiche da essa perseguite. L’idea della
funzione formativa della cultura portò al tempo stesso a una concezione nuova
dell’educazione ispirando nella teoria e nella pratica la pedagogia di P. P. Vergerio,
di Guarino de’ Guarini, di Maffeo Vegio, di Vittorino da Feltre. Quello che in ogni
campo si faceva valere era comunque il principio della dignità dell’uomo, tema
essenziale, che dal De dignitate et excellentia hominis di Giannozzo Manetti alla
sintesi tentata dal Ficino tra cristianesimo e platonismo costituì l’obiettivo più alto
del pensiero umanistico. La linea di sviluppo dell’Umanesimo, benché segnata da
una fondamentale coerenza, fu tuttavia complicata non solo dal rapido progresso
degli studi con le conseguenti ripercussioni nel campo sia speculativo sia pratico, ma
anche dall’evolversi della società italiana. Nella crisi che portò dal tramonto delle
ultime libertà comunali a un regime di signorie e di principati venne affermandosi
una società capitalistica, i cui ideali e le cui contraddizioni si rispecchiano nella
filosofia degli umanisti. Così se la difesa delle virtù pratiche nel Bracciolini
significa soprattutto il rifiuto dell’ascetismo medievale, l’epicureismo del Valla e il
suo tentativo di accordare nel De libero arbitrio la concezione epicurea con la
morale cristiana segnano il passaggio a una più drammatica situazione storica.
D’altra parte la difesa della famiglia come dell’istituto che, grazie a un’avveduta
amministrazione, offre all’uomo la sola sicura difesa contro i colpi della fortuna, sta
a testimoniare nell’Alberti una motivata diffidenza verso un assetto politico dal
quale la giovane società capitalistica riceveva impulso senza peraltro ottenere le
desiderate garanzie di stabilità. È pur vero che se il mecenatismo dei principi
consentì agli umanisti di dedicarsi agli studi in condizioni privilegiate, esso venne
altresì a condizionare e a limitare la loro indipendenza, e non fu questa l’ultima
causa del progressivo esaurirsi degli impulsi morali e politici che avevano favorito
l’affermarsi della nuova cultura.
Ma intanto l’eredità della nuova cultura si trasmetteva alla letteratura volgare del
maturo Rinascimento e avrebbe dato suoi frutti fuori d’Italia, non solo nella grande
filologia di Reuchlin, Erasmo da Rotterdam, G. Bude, H. Estienne, G. G. Scaligero,
ma nel pensiero stesso dei riformatori, che in condizioni sociali diverse,
interpretando alla luce dello spirito critico diffuso dall’Umanesimo esigenze delle
masse popolari, attuarono una rivoluzione gravida di conseguenze, oltre che sul
piano religioso, su quello politico e sociale.
Bibliogr.: Diamo qui di seguito solo alcuni riferimenti essenziali, che possono essere
integrati con la bibliografia della voce Rinascimento’; G. Saitta, Il pensiero italiano