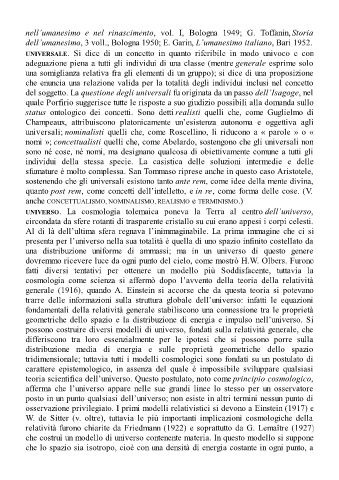Page 850 - Dizionario di Filosofia
P. 850
nell’umanesimo e nel rinascimento, vol. I, Bologna 1949; G. Toffanin, Storia
dell’umanesimo, 3 voll., Bologna 1950; E. Garin, L’umanesimo italiano, Bari 1952.
UNIVERSALE. Si dice di un concetto in quanto riferibile in modo univoco e con
adeguazione piena a tutti gli individui di una classe (mentre generale esprime solo
una somiglianza relativa fra gli elementi di un gruppo); si dice di una proposizione
che enuncia una relazione valida per la totalità degli individui inclusi nel concetto
del soggetto. La questione degli universali fu originata da un passo dell’Isagoge, nel
quale Porfirio suggerisce tutte le risposte a suo giudizio possibili alla domanda sullo
status ontologico dei concetti. Sono detti realisti quelli che, come Guglielmo di
Champeaux, attribuiscono platonicamente un’esistenza autonoma e oggettiva agli
universali; nominalisti quelli che, come Roscellino, li riducono a « parole » o «
nomi »; concettualisti quelli che, come Abelardo, sostengono che gli universali non
sono né cose, né nomi, ma designano qualcosa di obiettivamente comune a tutti gli
individui della stessa specie. La casistica delle soluzioni intermedie e delle
sfumature è molto complessa. San Tommaso riprese anche in questo caso Aristotele,
sostenendo che gli universali esistono tanto ante rem, come idee della mente divina,
quanto post rem, come concetti dell’intelletto, e in re, come forma delle cose. (V.
anche CONCETTUALISMO, NOMINALISMO, REALISMO e TERMINISMO.)
UNIVERSO. La cosmologia tolemaica poneva la Terra al centro dell’universo,
circondata da sfere rotanti di trasparente cristallo su cui erano appesi i corpi celesti.
Al di là dell’ultima sfera regnava l’inimmaginabile. La prima immagine che ci si
presenta per l’universo nella sua totalità è quella di uno spazio infinito costellato da
una distribuzione uniforme di ammassi; ma in un universo di questo genere
dovremmo ricevere luce da ogni punto del cielo, come mostrò H.W. Olbers. Furono
fatti diversi tentativi per ottenere un modello più Soddisfacente, tuttavia la
cosmologia come scienza si affermò dopo l’avvento della teoria della relatività
generale (1916), quando A. Einstein si accorse che da questa teoria si potevano
trarre delle informazioni sulla struttura globale dell’universo: infatti le equazioni
fondamentali della relatività generale stabiliscono una connessione tra le proprietà
geometriche dello spazio e la distribuzione di energia e impulso nell’universo. Si
possono costruire diversi modelli di universo, fondati sulla relatività generale, che
differiscono tra loro essenzialmente per le ipotesi che si possono porre sulla
distribuzione media di energia e sulle proprietà geometriche dello spazio
tridimensionale; tuttavia tutti i modelli cosmologici sono fondati su un postulato di
carattere epistemologico, in assenza del quale è impossibile sviluppare qualsiasi
teoria scientifica dell’universo. Questo postulato, noto come principio cosmologico,
afferma che l’universo appare nelle sue grandi linee lo stesso per un osservatore
posto in un punto qualsiasi dell’universo; non esiste in altri termini nessun punto di
osservazione privilegiato. I primi modelli relativistici si devono a Einstein (1917) e
W. de Sitter (v. oltre), tuttavia le più importanti implicazioni cosmologiche della
relatività furono chiarite da Friedmann (1922) e soprattutto da G. Lemaître (1927)
che costruì un modello di universo contenente materia. In questo modello si suppone
che lo spazio sia isotropo, cioè con una densità di energia costante in ogni punto, a