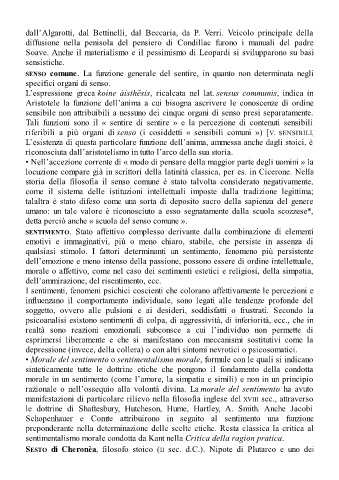Page 767 - Dizionario di Filosofia
P. 767
dall’Algarotti, dal Bettinelli, dal Beccaria, da P. Verri. Veicolo principale della
diffusione nella penisola del pensiero di Condillac furono i manuali del padre
Soave. Anche il materialismo e il pessimismo di Leopardi si svilupparono su basi
sensistiche.
SENSO comune. La funzione generale del sentire, in quanto non determinata negli
specifici organi di senso.
L’espressione greca koine áisthēsis, ricalcata nel lat. sensus communis, indica in
Aristotele la funzione dell’anima a cui bisogna ascrivere le conoscenze di ordine
sensibile non attribuibili a nessuno dei cinque organi di senso presi separatamente.
Tali funzioni sono il « sentire di sentire » e la percezione di contenuti sensibili
riferibili a più organi di senso (i cosiddetti « sensibili comuni ») [V. SENSIBILI].
L’esistenza di questa particolare funzione dell’anima, ammessa anche dagli stoici, è
riconosciuta dall’aristotelismo in tutto l’arco della sua storia.
• Nell’accezione corrente di « modo di pensare della maggior parte degli uomini » la
locuzione compare già in scrittori della latinità classica, per es. in Cicerone. Nella
storia della filosofia il senso comune è stato talvolta considerato negativamente,
come il sistema delle istituzioni intellettuali imposte dalla tradizione legittima;
talaltra è stato difeso come una sorta di deposito sacro della sapienza del genere
umano: un tale valore è riconosciuto a esso segnatamente dalla scuola scozzese*,
detta perciò anche « scuola del senso comune ».
SENTIMENTO. Stato affettivo complesso derivante dalla combinazione di elementi
emotivi e immaginativi, più o meno chiaro, stabile, che persiste in assenza di
qualsiasi stimolo. I fattori determinanti un sentimento, fenomeno più persistente
dell’emozione e meno intenso della passione, possono essere di ordine intellettuale,
morale o affettivo, come nel caso dei sentimenti estetici e religiosi, della simpatia,
dell’ammirazione, del risentimento, ecc.
I sentimenti, fenomeni psichici coscienti che colorano affettivamente le percezioni e
influenzano il comportamento individuale, sono legati alle tendenze profonde del
soggetto, ovvero alle pulsioni e ai desideri, soddisfatti o frustrati. Secondo la
psicoanalisi esistono sentimenti di colpa, di aggressività, di inferiorità, ecc., che in
realtà sono reazioni emozionali subconsce a cui l’individuo non permette di
esprimersi liberamente e che si manifestano con meccanismi sostitutivi come la
depressione (invece, della collera) o con altri sintomi nevrotici o psicosomatici.
• Morale del sentimento o sentimentalismo morale, formule con le quali si indicano
sinteticamente tutte le dottrine etiche che pongono il fondamento della condotta
morale in un sentimento (come l’amore, la simpatia e simili) e non in un principio
razionale o nell’ossequio alla volontà divina. La morale del sentimento ha avuto
manifestazioni di particolare rilievo nella filosofia inglese del XVIII sec., attraverso
le dottrine di Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Hartley, A. Smith. Anche Jacobi,
Schopenhauer e Comte attribuirono in seguito al sentimento una funzione
preponderante nella determinazione delle scelte etiche. Resta classica la critica al
sentimentalismo morale condotta da Kant nella Critica della ragion pratica.
SESTO di Cheronèa, filosofo stoico (II sec. d.C.). Nipote di Plutarco e uno dei