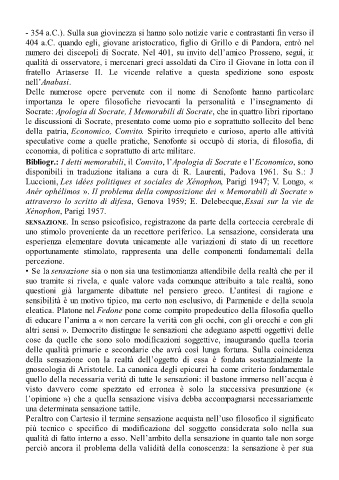Page 765 - Dizionario di Filosofia
P. 765
- 354 a.C.). Sulla sua giovinezza si hanno solo notizie varie e contrastanti fin verso il
404 a.C. quando egli, giovane aristocratico, figlio di Grillo e di Pandora, entrò nel
numero dei discepoli di Socrate. Nel 401, su invito dell’amico Prosseno, seguì, in
qualità di osservatore, i mercenari greci assoldati da Ciro il Giovane in lotta con il
fratello Artaserse II. Le vicende relative a questa spedizione sono esposte
nell’Anabasi.
Delle numerose opere pervenute con il nome di Senofonte hanno particolare
importanza le opere filosofiche rievocanti la personalità e l’insegnamento di
Socrate: Apologia di Socrate, I Memorabili di Socrate, che in quattro libri riportano
le discussioni di Socrate, presentato come uomo pio e soprattutto sollecito del bene
della patria, Economico, Convito. Spirito irrequieto e curioso, aperto alle attività
speculative come a quelle pratiche, Senofonte si occupò di storia, di filosofia, di
economia, di politica e soprattutto di arte militare.
Bibliogr.: I detti memorabili, il Convito, l’Apologia di Socrate e l’Economico, sono
disponibili in traduzione italiana a cura di R. Laurenti, Padova 1961. Su S.: J.
Luccioni, Les idées politiques et sociales de Xénophon, Parigi 1947; V. Longo, «
Anér ophélimos ». Il problema della composizione dei « Memorabili di Socrate »
attraverso lo scritto di difesa, Genova 1959; E. Delebecque, Essai sur la vie de
Xénophon, Parigi 1957.
SENSAZIONE. In senso psicofisico, registrazone da parte della corteccia cerebrale di
uno stimolo proveniente da un recettore periferico. La sensazione, considerata una
esperienza elementare dovuta unicamente alle variazioni di stato di un recettore
opportunamente stimolato, rappresenta una delle componenti fondamentali della
percezione.
• Se la sensazione sia o non sia una testimonianza attendibile della realtà che per il
suo tramite si rivela, e quale valore vada comunque attribuito a tale realtà, sono
questioni già largamente dibattute nel pensiero greco. L’antitesi di ragione e
sensibilità è un motivo tipico, ma certo non esclusivo, di Parmenide e della scuola
eleatica. Platone nel Fedone pone come compito propedeutico della filosofia quello
di educare l’anima a « non cercare la verità con gli occhi, con gli orecchi e con gli
altri sensi ». Democrito distingue le sensazioni che adeguano aspetti oggettivi delle
cose da quelle che sono solo modificazioni soggettive, inaugurando quella teoria
delle qualità primarie e secondarie che avrà così lunga fortuna. Sulla coincidenza
della sensazione con la realtà dell’oggetto di essa è fondata sostanzialmente la
gnoseologia di Aristotele. La canonica degli epicurei ha come criterio fondamentale
quello della necessaria verità di tutte le sensazioni: il bastone immerso nell’acqua è
visto davvero come spezzato ed erronea è solo la successiva presunzione («
l’opinione ») che a quella sensazione visiva debba accompagnarsi necessariamente
una determinata sensazione tattile.
Peraltro con Cartesio il termine sensazione acquista nell’uso filosofico il significato
più tecnico e specifico di modificazione del soggetto considerata solo nella sua
qualità di fatto interno a esso. Nell’ambito della sensazione in quanto tale non sorge
perciò ancora il problema della validità della conoscenza: la sensazione è per sua