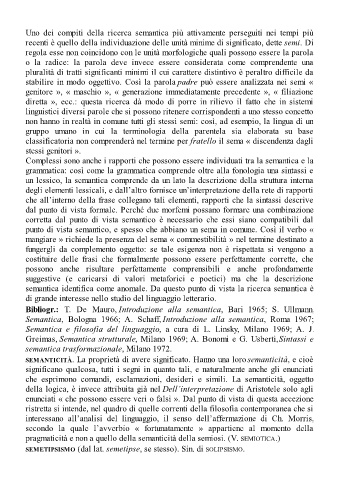Page 761 - Dizionario di Filosofia
P. 761
Uno dei compiti della ricerca semantica più attivamente perseguiti nei tempi più
recenti è quello della individuazione delle unità minime di significato, dette semi. Di
regola esse non coincidono con le unità morfologiche quali possono essere la parola
o la radice: la parola deve invece essere considerata come comprendente una
pluralità di tratti significanti minimi il cui carattere distintivo è peraltro difficile da
stabilire in modo oggettivo. Così la parola padre può essere analizzata nei semi «
genitore », « maschio », « generazione immediatamente precedente », « filiazione
diretta », ecc.: questa ricerca dà modo di porre in rilievo il fatto che in sistemi
linguistici diversi parole che si possono ritenere corrispondenti a uno stesso concetto
non hanno in realtà in comune tutti gli stessi semi: così, ad esempio, la lingua di un
gruppo umano in cui la terminologia della parentela sia elaborata su base
classificatoria non comprenderà nel termine per fratello il sema « discendenza dagli
stessi genitori ».
Complessi sono anche i rapporti che possono essere individuati tra la semantica e la
grammatica: così come la grammatica comprende oltre alla fonologia una sintassi e
un lessico, la semantica comprende da un lato la descrizione della struttura interna
degli elementi lessicali, e dall’altro fornisce un’interpretazione della rete di rapporti
che all’interno della frase collegano tali elementi, rapporti che la sintassi descrive
dal punto di vista formale. Perché due morfemi possano formare una combinazione
corretta dal punto di vista semantico è necessario che essi siano compatibili dal
punto di vista semantico, e spesso che abbiano un sema in comune. Così il verbo «
mangiare » richiede la presenza del sema « commestibilità » nel termine destinato a
fungergli da complemento oggetto: se tale esigenza non è rispettata si vengono a
costituire delle frasi che formalmente possono essere perfettamente corrette, che
possono anche risultare perfettamente comprensibili e anche profondamente
suggestive (e caricarsi di valori metaforici e poetici) ma che la descrizione
semantica identifica come anomale. Da questo punto di vista la ricerca semantica è
di grande interesse nello studio del linguaggio letterario.
Bibliogr.: T. De Mauro, Introduzione alla semantica, Bari 1965; S. Ullmann,
Semantica, Bologna 1966; A. Schaff, Introduzione alla semantica, Roma 1967;
Semantica e filosofia del linguaggio, a cura di L. Linsky, Milano 1969; A. J.
Greimas, Semantica strutturale, Milano 1969; A. Bonomi e G. Usberti, Sintassi e
semantica trasformazionale, Milano 1972.
SEMANTICITÀ. La proprietà di avere significato. Hanno una loro semanticità, e cioè
significano qualcosa, tutti i segni in quanto tali, e naturalmente anche gli enunciati
che esprimono comandi, esclamazioni, desideri e simili. La semanticità, oggetto
della logica, è invece attribuita già nel Dell’interpretazione di Aristotele solo agli
enunciati « che possono essere veri o falsi ». Dal punto di vista di questa accezione
ristretta si intende, nel quadro di quelle correnti della filosofia contemporanea che si
interessano all’analisi del linguaggio, il senso dell’affermazione di Ch. Morris,
secondo la quale l’avverbio « fortunatamente » appartiene al momento della
pragmaticità e non a quello della semanticità della semiosi. (V. SEMIOTICA.)
SEMETIPSISMO (dal lat. semetipse, se stesso). Sin. di SOLIPSISMO.