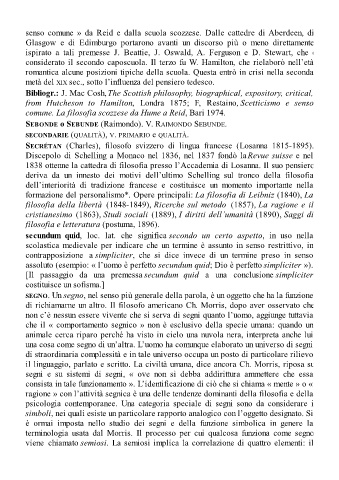Page 759 - Dizionario di Filosofia
P. 759
senso comune » da Reid e dalla scuola scozzese. Dalle cattedre di Aberdeen, di
Glasgow e di Edimburgo portarono avanti un discorso più o meno direttamente
ispirato a tali premesse J. Beattie, J. Oswald, A. Ferguson e D. Stewart, che è
considerato il secondo caposcuola. Il terzo fu W. Hamilton, che rielaborò nell’età
romantica alcune posizioni tipiche della scuola. Questa entrò in crisi nella seconda
metà del XIX sec., sotto l’influenza del pensiero tedesco.
Bibliogr.: J. Mac Cosh, The Scottish philosophy, biographical, expository, critical,
from Hutcheson to Hamilton, Londra 1875; F, Restaino, Scetticismo e senso
comune. La filosofia scozzese da Hume a Reid, Bari 1974.
SEBONDE o SEBUNDE (Raimondo). V. RAIMONDO SEBUNDE.
SECONDARIE (QUALITÀ), V. PRIMARIO e QUALITÀ.
SECRÉTAN (Charles), filosofo svizzero di lingua francese (Losanna 1815-1895).
Discepolo di Schelling a Monaco nel 1836, nel 1837 fondò la Revue suisse e nel
1838 ottenne la cattedra di filosofia presso l’Accademia di Losanna. Il suo pensiero
deriva da un innesto dei motivi dell’ultimo Schelling sul tronco della filosofia
dell’interiorità di tradizione francese e costituisce un momento importante nella
formazione del personalismo*. Opere principali: La filosofia di Leibniz (1840), La
filosofia della libertà (1848-1849), Ricerche sul metodo (1857), La ragione e il
cristianesimo (1863), Studi sociali (1889), I diritti dell’umanità (1890), Saggi di
filosofia e letteratura (postuma, 1896).
secundum quid, loc. lat. che significa secondo un certo aspetto, in uso nella
scolastica medievale per indicare che un termine è assunto in senso restrittivo, in
contrapposizione a simpliciter, che si dice invece di un termine preso in senso
assoluto (esempio: « l’uomo è perfetto secundum quid; Dio è perfetto simpliciter »).
[Il passaggio da una premessa secundum quid a una conclusione simpliciter
costituisce un sofisma.]
SEGNO. Un segno, nel senso più generale della parola, è un oggetto che ha la funzione
di richiamarne un altro. Il filosofo americano Ch. Morris, dopo aver osservato che
non c’è nessun essere vivente che si serva di segni quanto l’uomo, aggiunge tuttavia
che il « comportamento segnico » non è esclusivo della specie umana: quando un
animale cerca riparo perché ha visto in cielo una nuvola nera, interpreta anche lui
una cosa come segno di un’altra. L’uomo ha comunque elaborato un universo di segni
di straordinaria complessità e in tale universo occupa un posto di particolare rilievo
il linguaggio, parlato e scritto. La civiltà umana, dice ancora Ch. Morris, riposa su
segni e su sistemi di segni, « ove non si debba addirittura ammettere che essa
consista in tale funzionamento ». L’identificazione di ciò che si chiama « mente » o «
ragione » con l’attività segnica è una delle tendenze dominanti della filosofia e della
psicologia contemporanee. Una categoria speciale di segni sono da considerare i
simboli, nei quali esiste un particolare rapporto analogico con l’oggetto designato. Si
è ormai imposta nello studio dei segni e della funzione simbolica in genere la
terminologia usata dal Morris. Il processo per cui qualcosa funziona come segno
viene chiamato semiosi. La semiosi implica la correlazione di quattro elementi: il