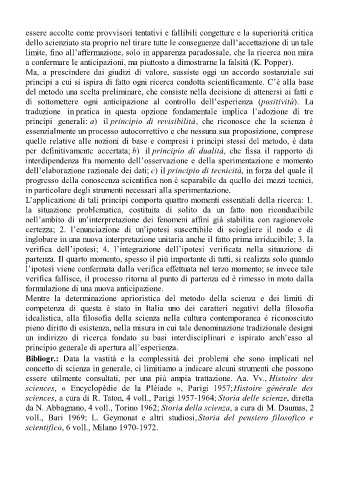Page 754 - Dizionario di Filosofia
P. 754
essere accolte come provvisori tentativi e fallibili congetture e la superiorità critica
dello scienziato sta proprio nel tirare tutte le conseguenze dall’accettazione di un tale
limite, fino all’affermazione, solo in apparenza paradossale, che la ricerca non mira
a confermare le anticipazioni, ma piuttosto a dimostrarne la falsità (K. Popper).
Ma, a prescindere dai giudizi di valore, sussiste oggi un accordo sostanziale sui
principi a cui si ispira di fatto ogni ricerca condotta scientificamente. C’è alla base
del metodo una scelta preliminare, che consiste nella decisione di attenersi ai fatti e
di sottomettere ogni anticipazione al controllo dell’esperienza (positività). La
traduzione in pratica in questa opzione fondamentale implica l’adozione di tre
principi generali: a) il principio di revisibilità, che riconosce che la scienza è
essenzialmente un processo autocorrettivo e che nessuna sua proposizione, comprese
quelle relative alle nozioni di base e compresi i principi stessi del metodo, è data
per definitivamente accertata; b) il principio di dualità, che fissa il rapporto di
interdipendenza fra momento dell’osservazione e della sperimentazione e momento
dell’elaborazione razionale dei dati; c) il principio di tecnicità, in forza del quale il
progresso della conoscenza scientifica non è separabile da quello dei mezzi tecnici,
in particolare degli strumenti necessari alla sperimentazione.
L’applicazione di tali principi comporta quattro momenti essenziali della ricerca: 1.
la situazione problematica, costituita di solito da un fatto non riconducibile
nell’ambito di un’interpretazione dei fenomeni affini già stabilita con ragionevole
certezza; 2. l’enunciazione di un’ipotesi suscettibile di sciogliere il nodo e di
inglobare in una nuova interpretazione unitaria anche il fatto prima irriducibile; 3. la
verifica dell’ipotesi; 4. l’integrazione dell’ipotesi verificata nella situazione di
partenza. Il quarto momento, spesso il più importante di tutti, si realizza solo quando
l’ipotesi viene confermata dalla verifica effettuata nel terzo momento; se invece tale
verifica fallisce, il processo ritorna al punto di partenza ed è rimesso in moto dalla
formulazione di una nuova anticipazione.
Mentre la determinazione aprioristica del metodo della scienza e dei limiti di
competenza di questa è stato in Italia uno dei caratteri negativi della filosofia
idealistica, alla filosofia della scienza nella cultura contemporanea è riconosciuto
pieno diritto di esistenza, nella misura in cui tale denominazione tradizionale designi
un indirizzo di ricerca fondato su basi interdisciplinari e ispirato anch’esso al
principio generale di apertura all’esperienza.
Bibliogr.: Data la vastità e la complessità dei problemi che sono implicati nel
concetto di scienza in generale, ci limitiamo a indicare alcuni strumenti che possono
essere utilmente consultati, per una più ampia trattazione. Aa. Vv., Histoire des
sciences, « Encyclopédie de la Pléiade », Parigi 1957; Histoire générale des
sciences, a cura di R. Taton, 4 voll., Parigi 1957-1964; Storia delle scienze, diretta
da N. Abbagnano, 4 voll., Torino 1962; Storia della scienza, a cura di M. Daumas, 2
voll., Bari 1969; L. Geymonat e altri studiosi, Storia del pensiero filosofico e
scientifico, 6 voll., Milano 1970-1972.