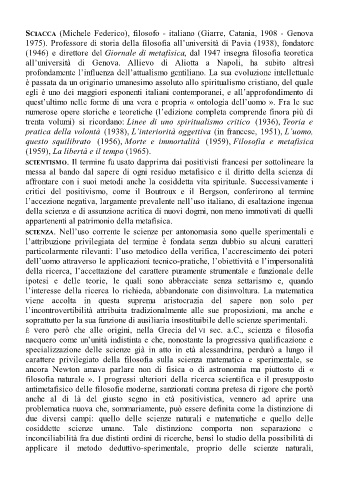Page 751 - Dizionario di Filosofia
P. 751
SCIACCA (Michele Federico), filosofo - italiano (Giarre, Catania, 1908 - Genova,
1975). Professore di storia della filosofia all’università di Pavia (1938), fondatore
(1946) e direttore del Giornale di metafisica, dal 1947 insegna filosofia teoretica
all’università di Genova. Allievo di Aliotta a Napoli, ha subito altresì
profondamente l’influenza dell’attualismo gcntiliano. La sua evoluzione intellettuale
è passata da un originario umanesimo assoluto allo spiritualismo cristiano, del quale
egli è uno dei maggiori esponenti italiani contemporanei, e all’approfondimento di
quest’ultimo nelle forme di una vera e propria « ontologia dell’uomo ». Fra le sue
numerose opere storiche e teoretiche (l’edizione completa comprende finora più di
trenta volumi) si ricordano: Linee di uno spiritualismo critico (1936), Teoria e
pratica della volontà (1938), L’interiorità oggettiva (in francese, 1951), L’uomo,
questo squilibrato (1956), Morte e immortalità (1959), Filosofia e metafisica
(1959), La libertà e il tempo (1965).
SCIENTISMO. Il termine fu usato dapprima dai positivisti francesi per sottolineare la
messa al bando dal sapere di ogni residuo metafisico e il diritto della scienza di
affrontare con i suoi metodi anche la cosiddetta vita spirituale. Successivamente i
critici del positivismo, come il Boutroux e il Bergson, conferirono al termine
l’accezione negativa, largamente prevalente nell’uso italiano, di esaltazione ingenua
della scienza e di assunzione acritica di nuovi dogmi, non meno immotivati di quelli
appartenenti al patrimonio della metafìsica.
SCIENZA. Nell’uso corrente le scienze per antonomasia sono quelle sperimentali e
l’attribuzione privilegiata del termine è fondata senza dubbio su alcuni caratteri
particolarmente rilevanti: l’uso metodico della verifica, l’accrescimento dei poteri
dell’uomo attraverso le applicazioni tecnico-pratiche, l’obiettività e l’impersonalità
della ricerca, l’accettazione del carattere puramente strumentale e funzionale delle
ipotesi e delle teorie, le quali sono abbracciate senza settarismo e, quando
l’interesse della ricerca lo richieda, abbandonate con disinvoltura. La matematica
viene accolta in questa suprema aristocrazia del sapere non solo per
l’incontrovertibilità attribuita tradizionalmente alle sue proposizioni, ma anche e
soprattutto per la sua funzione di ausiliaria insostituibile delle scienze sperimentali.
È vero però che alle origini, nella Grecia del VI sec. a.C., scienza e filosofia
nacquero come un’unità indistinta e che, nonostante la progressiva qualificazione e
specializzazione delle scienze già in atto in età alessandrina, perdurò a lungo il
carattere privilegiato della filosofia sulla scienza matematica e sperimentale, se
ancora Newton amava parlare non di fisica o di astronomia ma piuttosto di «
filosofia naturale ». I progressi ulteriori della ricerca scientifica e il presupposto
antimetafisico delle filosofie moderne, sanzionati conuna pretesa di rigore che portò
anche al di là del giusto segno in età positivistica, vennero ad aprire una
problematica nuova che, sommariamente, può essere definita come la distinzione di
due diversi campi: quello delle scienze naturali e matematiche e quello delle
cosiddette scienze umane. Tale distinzione comporta non separazione e
inconciliabilità fra due distinti ordini di ricerche, bensì lo studio della possibilità di
applicare il metodo deduttivo-sperimentale, proprio delle scienze naturali,