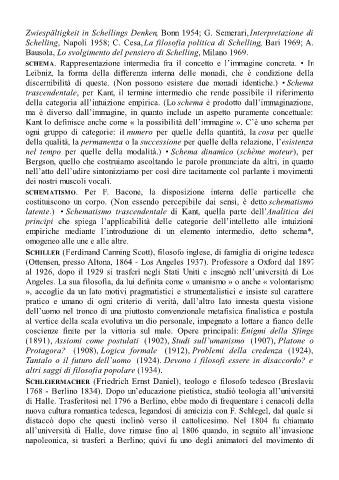Page 746 - Dizionario di Filosofia
P. 746
Zwiespältigkeit in Schellings Denken, Bonn 1954; G. Semerari, Interpretazione di
Schelling, Napoli 1958; C. Cesa, La filosofia politica di Schelling, Bari 1969; A.
Bausola, Lo svolgimento del pensiero di Schelling, Milano 1969.
SCHEMA. Rappresentazione intermedia fra il concetto e l’immagine concreta. • In
Leibniz, la forma della differenza interna delle monadi, che è condizione della
discernibilità di queste. (Non possono esistere due monadi identiche.) • Schema
trascendentale, per Kant, il termine intermedio che rende possibile il riferimento
della categoria all’intuizione empirica. (Lo schema è prodotto dall’immaginazione,
ma è diverso dall’immagine, in quanto include un aspetto puramente concettuale:
Kant lo definisce anche come « la possibilità dell’immagine ». C’è uno schema per
ogni gruppo di categorie: il numero per quelle della quantità, la cosa per quelle
della qualità, la permanenza o la successione per quelle della relazione, l’esistenza
nel tempo per quelle della modalità.) • Schema dinamico (schème moteur), per
Bergson, quello che costruiamo ascoltando le parole pronunciate da altri, in quanto
nell’atto dell’udire sintonizziamo per così dire tacitamente col parlante i movimenti
dei nostri muscoli vocali.
SCHEMATISMO. Per F. Bacone, la disposizione interna delle particelle che
costituiscono un corpo. (Non essendo percepibile dai sensi, è detto schematismo
latente.) • Schematismo trascendentale di Kant, quella parte dell’Analitica dei
principi che spiega l’applicabilità delle categorie dell’intelletto alle intuizioni
empiriche mediante l’introduzione di un elemento intermedio, detto schema*,
omogeneo alle une e alle altre.
SCHILLER (Ferdinand Canning Scott), filosofo inglese, di famiglia di origine tedesca
(Ottensen, presso Altona, 1864 - Los Angeles 1937). Professore a Oxford dal 1897
al 1926, dopo il 1929 si trasferì negli Stati Uniti e insegnò nell’università di Los
Angeles. La sua filosofia, da lui definita come « umanismo » o anche « volontarismo
», accoglie da un lato motivi pragmatistici e strumentalistici e insiste sul carattere
pratico e umano di ogni criterio di verità, dall’altro lato innesta questa visione
dell’uomo nel tronco di una piuttosto convenzionale metafisica finalistica e postula
al vertice della scala evolutiva un dio personale, impegnato a lottare a fianco delle
coscienze finite per la vittoria sul male. Opere principali: Enigmi della Sfinge
(1891), Assiomi come postulati (1902), Studi sull’umanismo (1907), Platone o
Protagora? (1908), Logica formale (1912), Problemi della credenza (1924),
Tantalo o il futuro dell’uomo (1924). Devono i filosofi essere in disaccordo? e
altri saggi di filosofia popolare (1934).
SCHLEIERMACHER (Friedrich Ernst Daniel), teologo e filosofo tedesco (Breslavia
1768 - Berlino 1834). Dopo un’educazione pietistica, studiò teologia all’università
di Halle. Trasferitosi nel 1796 a Berlino, ebbe modo di frequentare i cenacoli della
nuova cultura romantica tedesca, legandosi di amicizia con F. Schlegel, dal quale si
distaccò dopo che questi inclinò verso il cattolicesimo. Nel 1804 fu chiamato
all’università di Halle, dove rimase fino al 1806 quando, in seguito all’invasione
napoleonica, si trasferì a Berlino; quivi fu uno degli animatori del movimento di