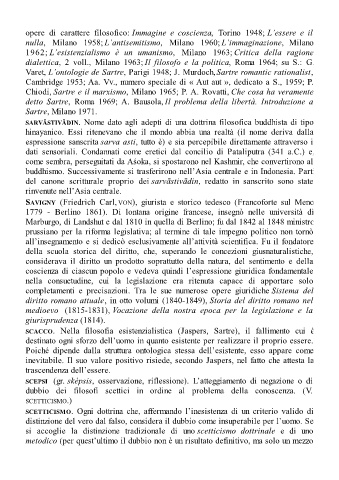Page 741 - Dizionario di Filosofia
P. 741
opere di carattere filosofico: Immagine e coscienza, Torino 1948; L’essere e il
nulla, Milano 1958; L’antisemitismo, Milano 1960; L’immaginazione, Milano
1962; L’esistenzialismo è un umanismo, Milano 1963; Critica della ragione
dialettica, 2 voll., Milano 1963; Il filosofo e la politica, Roma 1964; su S.: G.
Varet, L’ontologie de Sartre, Parigi 1948; J. Murdoch, Sartre romantic rationalist,
Cambridge 1953; Aa. Vv., numero speciale di « Aut aut », dedicato a S., 1959; P.
Chiodi, Sartre e il marxismo, Milano 1965; P. A. Rovatti, Che cosa ha veramente
detto Sartre, Roma 1969; A. Bausola, Il problema della libertà. Introduzione a
Sartre, Milano 1971.
SARVĀSTIVĀDIN. Nome dato agli adepti di una dottrina filosofica buddhista di tipo
hinayanico. Essi ritenevano che il mondo abbia una realtà (il nome deriva dalla
espressione sanscrita sarva asti, tutto è) e sia percepibile direttamente attraverso i
dati sensoriali. Condannati come eretici dal concilio di Pataliputra (341 a.C.) e,
come sembra, perseguitati da Aśoka, si spostarono nel Kashmir, che convertirono al
buddhismo. Successivamente si trasferirono nell’Asia centrale e in Indonesia. Parti
del canone scritturale proprio dei sarvāstivādin, redatto in sanscrito sono state
rinvenute nell’Asia centrale.
SAVIGNY (Friedrich Carl, VON), giurista e storico tedesco (Francoforte sul Meno
1779 - Berlino 1861). Di lontana origine francese, insegnò nelle università di
Marburgo, di Landshut e dal 1810 in quella di Berlino; fu dal 1842 al 1848 ministro
prussiano per la riforma legislativa; al termine di tale impegno politico non tornò
all’insegnamento e si dedicò esclusivamente all’attività scientifica. Fu il fondatore
della scuola storica del diritto, che, superando le concezioni giusnaturalistiche,
considerava il diritto un prodotto soprattutto della natura, del sentimento e della
coscienza di ciascun popolo e vedeva quindi l’espressione giuridica fondamentale
nella consuetudine, cui la legislazione era ritenuta capace di apportare solo
completamenti e precisazioni. Tra le sue numerose opere giuridiche Sistema del
diritto romano attuale, in otto volumi (1840-1849), Storia del diritto romano nel
medioevo (1815-1831), Vocazione della nostra epoca per la legislazione e la
giurisprudenza (1814).
SCACCO. Nella filosofia esistenzialistica (Jaspers, Sartre), il fallimento cui è
destinato ogni sforzo dell’uomo in quanto esistente per realizzare il proprio essere.
Poiché dipende dalla struttura ontologica stessa dell’esistente, esso appare come
inevitabile. Il suo valore positivo risiede, secondo Jaspers, nel fatto che attesta la
trascendenza dell’essere.
SCEPSI (gr. sképsis, osservazione, riflessione). L’atteggiamento di negazione o di
dubbio dei filosofi scettici in ordine al problema della conoscenza. (V.
SCETTICISMO.)
SCETTICISMO. Ogni dottrina che, affermando l’inesistenza di un criterio valido di
distinzione del vero dal falso, considera il dubbio come insuperabile per l’uomo. Se
si accoglie la distinzione tradizionale di uno scetticismo dottrinale e di uno
metodico (per quest’ultimo il dubbio non è un risultato definitivo, ma solo un mezzo