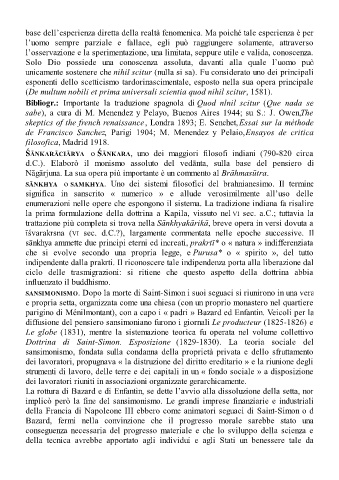Page 738 - Dizionario di Filosofia
P. 738
base dell’esperienza diretta della realtà fenomenica. Ma poiché tale esperienza è per
l’uomo sempre parziale e fallace, egli può raggiungere solamente, attraverso
l’osservazione e la sperimentazione, una limitata, seppure utile e valida, conoscenza.
Solo Dio possiede una conoscenza assoluta, davanti alla quale l’uomo può
unicamente sostenere che nihil scitur (nulla si sa). Fu considerato uno dei principali
esponenti dello scetticismo tardorinascimentale, esposto nella sua opera principale
(De multum nobili et prima universali scientia quod nihil scitur, 1581).
Bibliogr.: Importante la traduzione spagnola di Quod nlnil scitur (Que nada se
sabe), a cura di M. Menendez y Pelayo, Buenos Aires 1944; su S.: J. Owen, The
skeptics of the french renaissance, Londra 1893; E. Senchet, Essai sur la méthode
de Francisco Sanchez, Parigi 1904; M. Menendez y Pelaio, Ensayos de critica
filosofica, Madrid 1918.
ŚĀNKARĀCIĀRYA o ŚĀNKARA, uno dei maggiori filosofi indiani (790-820 circa
d.C.). Elaborò il monismo assoluto del vedānta, sulla base del pensiero di
Nāgārjuna. La sua opera più importante è un commento al Brāhmasūtra.
SĀNKHYA o SAMKHYA. Uno dei sistemi filosofici del brahnianesimo. Il termine
significa in sanscrito « numerico » e allude verosimilmente all’uso delle
enumerazioni nelle opere che espongono il sistema. La tradizione indiana fa risalire
la prima formulazione della dottrina a Kapila, vissuto nel VI sec. a.C.; tuttavia la
trattazione più completa si trova nella Sānkhyakārikā, breve opera in versi dovuta a
īśvarakrsna (VI sec. d.C.?), largamente commentata nelle epoche successive. Il
sānkhya ammette due principi eterni ed increati, prakrtī* o « natura » indifferenziata
che si evolve secondo una propria legge, e Purusa* o « spirito », del tutto
indipendente dalla prakrti. Il riconoscere tale indipendenza porta alla liberazione dal
ciclo delle trasmigrazioni: si ritiene che questo aspetto della dottrina abbia
influenzato il buddhismo.
SANSIMONISMO. Dopo la morte di Saint-Simon i suoi seguaci si riunirono in una vera
e propria setta, organizzata come una chiesa (con un proprio monastero nel quartiere
parigino di Ménilmontant), con a capo i « padri » Bazard ed Enfantin. Veicoli per la
diffusione del pensiero sansimoniano furono i giornali Le producteur (1825-1826) e
Le globe (1831), mentre la sistemazione teorica fu operata nel volume collettivo
Dottrina di Saint-Simon. Esposizione (1829-1830). La teoria sociale del
sansimonismo, fondata sulla condanna della proprietà privata e dello sfruttamento
dei lavoratori, propugnava « la distruzione del diritto ereditario » e la riunione degli
strumenti di lavoro, delle terre e dei capitali in un « fondo sociale » a disposizione
dei lavoratori riuniti in associazioni organizzate gerarchicamente.
La rottura di Bazard e di Enfantin, se dette l’avvio alla dissoluzione della setta, non
implicò però la fine del sansimonismo. Le grandi imprese finanziarie e industriali
della Francia di Napoleone III ebbero come animatori seguaci di Saint-Simon o di
Bazard, fermi nella convinzione che il progresso morale sarebbe stato una
conseguenza necessaria del progresso materiale e che lo sviluppo della scienza e
della tecnica avrebbe apportato agli individui e agli Stati un benessere tale da