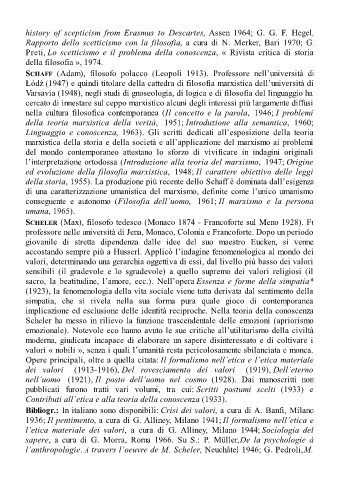Page 743 - Dizionario di Filosofia
P. 743
history of scepticism from Erasmus to Descartes, Assen 1964; G. G. F. Hegel,
Rapporto dello scetticismo con la filosofia, a cura di N. Merker, Bari 1970; G.
Preti, Lo scetticismo e il problema della conoscenza, « Rivista critica di storia
della filosofia », 1974.
SCHAFF (Adam), filosofo polacco (Leopoli 1913). Professore nell’università di
Łódź (1947) e quindi titolare della cattedra di filosofia marxistica dell’università di
Varsavia (1948), negli studi di gnoseologia, di logica e di filosofia del linguaggio ha
cercato di innestare sul ceppo marxistico alcuni degli interessi più largamente diffusi
nella cultura filosofica contemporanea (Il concetto e la parola, 1946; I problemi
della teoria marxistica della verità, 1951; Introduzione alla semantica, 1960;
Linguaggio e conoscenza, 1963). Gli scritti dedicati all’esposizione della teoria
marxistica della storia e della società e all’applicazione del marxismo ai problemi
del mondo contemporaneo attestano lo sforzo di vivificare in indagini originali
l’interpretazione ortodossa (Introduzione alla teoria del marxismo, 1947; Origine
ed evoluzione della filosofia marxistica, 1948; Il carattere obiettivo delle leggi
della storia, 1955). La produzione più recente dello Schaff è dominata dall’esigenza
di una caratterizzazione umanistica del marxismo, definite come l’unico umanismo
conseguente e autonomo (Filosofia dell’uomo, 1961; Il marxismo e la persona
umana, 1965).
SCHELER (Max), filosofo tedesco (Monaco 1874 - Francoforte sul Meno 1928). Fu
professore nelle università di Jena, Monaco, Colonia e Francoforte. Dopo un periodo
giovanile di stretta dipendenza dalle idee del suo maestro Eucken, si venne
accostando sempre più a Husserl. Applicò l’indagine fenomenologica al mondo dei
valori, determinando una gerarchia oggettiva di essi, dal livello più basso dei valori
sensibili (il gradevole e lo sgradevole) a quello supremo dei valori religiosi (il
sacro, la beatitudine, l’amore, ecc.). Nell’opera Essenza e forme della simpatia*
(1923), la fenomenologia della vita sociale viene tutta derivata dal sentimento della
simpatia, che si rivela nella sua forma pura quale gioco di contemporanea
implicazione ed esclusione delle identità reciproche. Nella teoria della conoscenza
Scheler ha messo in rilievo la funzione trascendentale delle emozioni (apriorismo
emozionale). Notevole eco hanno avuto le sue critiche all’utilitarismo della civiltà
moderna, giudicata incapace di elaborare un sapere disinteressato e di coltivare i
valori « nobili », senza i quali l’umanità resta pericolosamente sbilanciata e monca.
Opere principali, oltre a quella citata: Il formalismo nell’etica e l’etica materiale
dei valori (1913-1916), Del rovesciamento dei valori (1919), Dell’eterno
nell’uomo (1921), Il posto dell’uomo nel cosmo (1928). Dai manoscritti non
pubblicati furono tratti vari volumi, tra cui: Scritti postumi scelti (1933) e
Contributi all’etica e alla teoria della conoscenza (1933).
Bibliogr.: In italiano sono disponibili: Crisi dei valori, a cura di A. Banfi, Milano
1936; Il pentimento, a cura di G. Alliney, Milano 1941; Il formalismo nell’etica e
l’etica materiale dei valori, a cura di G. Alliney, Milano 1944; Sociologia del
sapere, a cura di G. Morra, Roma 1966. Su S.: P. Müller, De la psychologie à
l’anthropologie. À travers l’oeuvre de M. Scheler, Neuchâtel 1946; G. Pedroli, M.