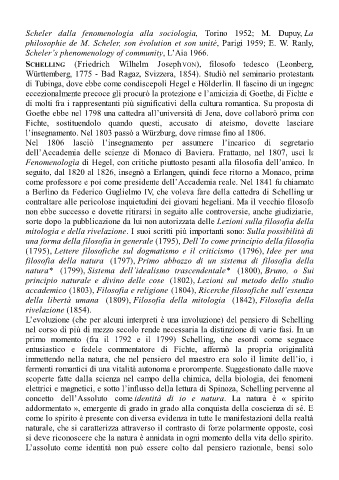Page 744 - Dizionario di Filosofia
P. 744
Scheler dalla fenomenologia alla sociologia, Torino 1952; M. Dupuy, La
philosophie de M. Scheler, son évolution et son unité, Parigi 1959; E. W. Ranly,
Scheler’s phenomenology of community, L’Aia 1966.
SCHELLING (Friedrich Wilhelm Joseph VON), filosofo tedesco (Leonberg,
Württemberg, 1775 - Bad Ragaz, Svizzera, 1854). Studiò nel seminario protestante
di Tubinga, dove ebbe come condiscepoli Hegel e Hölderlin. Il fascino di un ingegno
eccezionalmente precoce gli procurò la protezione e l’amicizia di Goethe, di Fichte e
di molti fra i rappresentanti più significativi della cultura romantica. Su proposta di
Goethe ebbe nel 1798 una cattedra all’università di Jena, dove collaborò prima con
Fichte, sostituendolo quando questi, accusato di ateismo, dovette lasciare
l’insegnamento. Nel 1803 passò a Würzburg, dove rimase fino al 1806.
Nel 1806 lasciò l’insegnamento per assumere l’incarico di segretario
dell’Accademia delle scienze di Monaco di Baviera. Frattanto, nel 1807, uscì la
Fenomenologìa di Hegel, con critiche piuttosto pesanti alla filosofia dell’amico. In
seguito, dal 1820 al 1826, insegnò a Erlangen, quindi fece ritorno a Monaco, prima
come professore e poi come presidente dell’Accademia reale. Nel 1841 fu chiamato
a Berlino da Federico Guglielmo IV, che voleva fare della cattedra di Schelling un
contraltare alle pericolose inquietudini dei giovani hegeliani. Ma il vecchio filosofo
non ebbe successo e dovette ritirarsi in seguito alle controversie, anche giudiziarie,
sorte dopo la pubblicazione da lui non autorizzata delle Lezioni sulla filosofia della
mitologia e della rivelazione. I suoi scritti più importanti sono: Sulla possibilità di
una forma della filosofia in generale (1795), Dell’Io come principio della filosofia
(1795), Lettere filosofiche sul dogmatismo e il criticismo (1796), Idee per una
filosofia della natura (1797), Primo abbozzo di un sistema di filosofia della
natura* (1799), Sistema dell’idealismo trascendentale* (1800), Bruno, o Sul
principio naturale e divino delle cose (1802), Lezioni sul metodo dello studio
accademico (1803), Filosofia e religione (1804), Ricerche filosofiche sull’essenza
della libertà umana (1809), Filosofia della mitologia (1842), Filosofia della
rivelazione (1854).
L’evoluzione (che per alcuni interpreti è una involuzione) del pensiero di Schelling
nel corso di più di mezzo secolo rende necessaria la distinzione di varie fasi. In un
primo momento (fra il 1792 e il 1799) Schelling, che esordì come seguace
entusiastico e fedele commentatore di Fichte, affermò la propria originalità
immettendo nella natura, che nel pensiero del maestro era solo il limite dell’io, i
fermenti romantici di una vitalità autonoma e prorompente. Suggestionato dalle nuove
scoperte fatte dalla scienza nel campo della chimica, della biologia, dei fenomeni
elettrici e magnetici, e sotto l’influsso della lettura di Spinoza, Schelling pervenne al
concetto dell’Assoluto come identità di io e natura. La natura è « spirito
addormentato », emergente di grado in grado alla conquista della coscienza di sé. E
come lo spirito è presente con diversa evidenza in tutte le manifestazioni della realtà
naturale, che si caratterizza attraverso il contrasto di forze polarmente opposte, così
si deve riconoscere che la natura è annidata in ogni momento della vita dello spirito.
L’assoluto come identità non può essere colto dal pensiero razionale, bensì solo