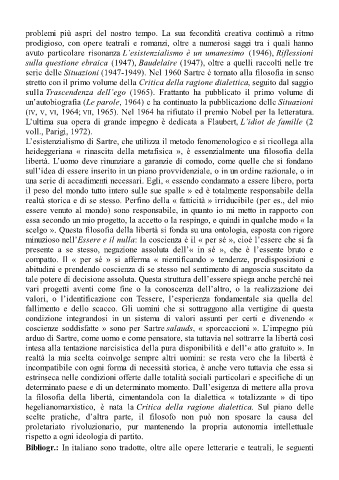Page 740 - Dizionario di Filosofia
P. 740
problemi più aspri del nostro tempo. La sua fecondità creativa continuò a ritmo
prodigioso, con opere teatrali e romanzi, oltre a numerosi saggi tra i quali hanno
avuto particolare risonanza L’esistenzialismo è un umanesimo (1946), Riflessioni
sulla questione ebraica (1947), Baudelaire (1947), oltre a quelli raccolti nelle tre
serie delle Situazioni (1947-1949). Nel 1960 Sartre è tornato alla filosofia in senso
stretto con il primo volume della Critica della ragione dialettica, seguito dal saggio
sulla Trascendenza dell’ego (1965). Frattanto ha pubblicato il primo volume di
un’autobiografia (Le parole, 1964) e ha continuato la pubblicazione delle Situazioni
(IV, V, VI, 1964; VII, 1965). Nel 1964 ha rifiutato il premio Nobel per la letteratura.
L’ultima sua opera di grande impegno è dedicata a Flaubert, L’idiot de famille (2
voll., Parigi, 1972).
L’esistenzialismo di Sartre, che utilizza il metodo fenomenologico e si ricollega alla
heideggeriana « rinascita della metafisica », è essenzialmente una filosofia della
libertà. L’uomo deve rinunziare a garanzie di comodo, come quelle che si fondano
sull’idea di essere inserito in un piano provvidenziale, o in un ordine razionale, o in
una serie di accadimenti necessari. Egli, « essendo condannato a essere libero, porta
il peso del mondo tutto intero sulle sue spalle » ed è totalmente responsabile della
realtà storica e di se stesso. Perfino della « fatticità » irriducibile (per es., del mio
essere venuto al mondo) sono responsabile, in quanto io mi metto in rapporto con
essa secondo un mio progetto, la accetto o la respingo, e quindi in qualche modo « la
scelgo ». Questa filosofia della libertà si fonda su una ontologia, esposta con rigore
minuzioso nell’Essere e il nulla: la coscienza è il « per sé », cioè l’essere che si fa
presente a se stesso, negazione assoluta dell’« in sé », che è l’essente bruto e
compatto. Il « per sé » si afferma « nientificando » tendenze, predisposizioni e
abitudini e prendendo coscienza di se stesso nel sentimento di angoscia suscitato da
tale potere di decisione assoluta. Questa struttura dell’essere spiega anche perché nei
vari progetti aventi come fine o la conoscenza dell’altro, o la realizzazione dei
valori, o l’identificazione con Tessere, l’esperienza fondamentale sia quella del
fallimento e dello scacco. Gli uomini che si sottraggono alla vertigine di questa
condizione integrandosi in un sistema di valori assunti per certi e divenendo «
coscienze soddisfatte » sono per Sartre salauds, « sporcaccioni ». L’impegno più
arduo di Sartre, come uomo e come pensatore, sta tuttavia nel sottrarre la libertà così
intesa alla tentazione narcisistica della pura disponibilità e dell’« atto gratuito ». In
realtà la mia scelta coinvolge sempre altri uomini: se resta vero che la libertà è
incompatibile con ogni forma di necessità storica, è anche vero tuttavia che essa si
estrinseca nelle condizioni offerte dalle totalità sociali particolari e specifiche di un
determinato paese e di un determinato momento. Dall’esigenza di mettere alla prova
la filosofia della libertà, cimentandola con la dialettica « totalizzante » di tipo
hegelianomarxistico, è nata la Critica della ragione dialettica. Sul piano delle
scelte pratiche, d’altra parte, il filosofo non può non sposare la causa del
proletariato rivoluzionario, pur mantenendo la propria autonomia intellettuale
rispetto a ogni ideologia di partito.
Bibliogr.: In italiano sono tradotte, oltre alle opere letterarie e teatrali, le seguenti