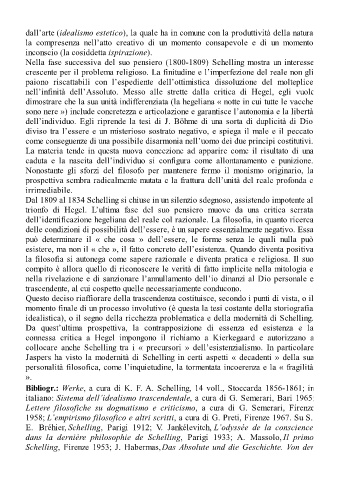Page 745 - Dizionario di Filosofia
P. 745
dall’arte (idealismo estetico), la quale ha in comune con la produttività della natura
la compresenza nell’atto creativo di un momento consapevole e di un momento
inconscio (la cosiddetta ispirazione).
Nella fase successiva del suo pensiero (1800-1809) Schelling mostra un interesse
crescente per il problema religioso. La finitudine e l’imperfezione del reale non gli
paiono riscattabili con l’espediente dell’ottimistica dissoluzione del molteplice
nell’infinità dell’Assoluto. Messo alle strette dalla critica di Hegel, egli vuole
dimostrare che la sua unità indifferenziata (la hegeliana « notte in cui tutte le vacche
sono nere ») include concretezza e articolazione e garantisce l’autonomia e la libertà
dell’individuo. Egli riprende la tesi di J. Böhme di una sorta di duplicità di Dio,
diviso tra l’essere e un misterioso sostrato negativo, e spiega il male e il peccato
come conseguenze di una possibile disarmonia nell’uomo dei due principi costitutivi.
La materia tende in questa nuova concezione ad apparire come il risultato di una
caduta e la nascita dell’individuo si configura come allontanamento e punizione.
Nonostante gli sforzi del filosofo per mantenere fermo il monismo originario, la
prospettiva sembra radicalmente mutata e la frattura dell’unità del reale profonda e
irrimediabile.
Dal 1809 al 1834 Schelling si chiuse in un silenzio sdegnoso, assistendo impotente al
trionfo di Hegel. L’ultima fase del suo pensiero muove da una critica serrata
dell’identificazione hegeliana del reale col razionale. La filosofia, in quanto ricerca
delle condizioni di possibilità dell’essere, è un sapere essenzialmente negativo. Essa
può determinare il « che cosa » dell’essere, le forme senza le quali nulla può
esistere, ma non il « che », il fatto concreto dell’esistenza. Quando diventa positiva
la filosofia si autonega come sapere razionale e diventa pratica e religiosa. Il suo
compito è allora quello di riconoscere le verità di fatto implicite nella mitologia e
nella rivelazione e di sanzionare l’annullamento dell’io dinanzi al Dio personale e
trascendente, al cui cospetto quelle necessariamente conducono.
Questo deciso riaffiorare della trascendenza costituisce, secondo i punti di vista, o il
momento finale di un processo involutivo (è questa la tesi costante della storiografia
idealistica), o il segno della ricchezza problematica e della modernità di Schelling.
Da quest’ultima prospettiva, la contrapposizione di essenza ed esistenza e la
connessa critica a Hegel impongono il richiamo a Kierkegaard e autorizzano a
collocare anche Schelling tra i « precursori » dell’esistenzialismo. In particolare
Jaspers ha visto la modernità di Schelling in certi aspetti « decadenti » della sua
personalità filosofica, come l’inquietudine, la tormentata incoerenza e la « fragilità
».
Bibliogr.: Werke, a cura di K. F. A. Schelling, 14 voll., Stoccarda 1856-1861; in
italiano: Sistema dell’idealismo trascendentale, a cura di G. Semerari, Bari 1965;
Lettere filosofiche su dogmatismo e criticismo, a cura di G. Semerari, Firenze
1958; L’empirismo filosofico e altri scritti, a cura di G. Preti, Firenze 1967. Su S.:
E. Bréhier, Schelling, Parigi 1912; V. Jankélevitch, L’odyssée de la conscience
dans la dernière philosophie de Schelling, Parigi 1933; A. Massolo, Il primo
Schelling, Firenze 1953; J. Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der