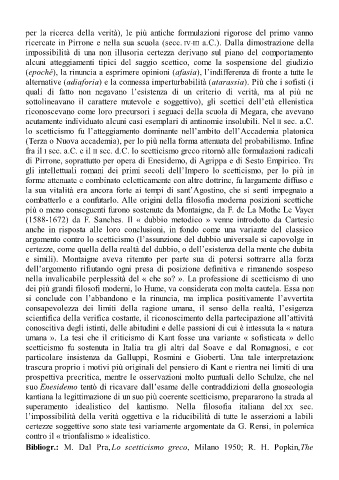Page 742 - Dizionario di Filosofia
P. 742
per la ricerca della verità), le più antiche formulazioni rigorose del primo vanno
ricercate in Pirrone e nella sua scuola (secc. IV-III a.C.). Dalla dimostrazione della
impossibilità di una non illusoria certezza derivano sul piano del comportamento
alcuni atteggiamenti tipici del saggio scettico, come la sospensione del giudizio
(epoché), la rinuncia a esprimere opinioni (afasia), l’indifferenza di fronte a tutte le
alternative (adiaforia) e la connessa imperturbabilità (atarassia). Più che i sofisti (i
quali di fatto non negavano l’esistenza di un criterio di verità, ma al più ne
sottolineavano il carattere mutevole e soggettivo), gli scettici dell’età ellenistica
riconoscevano come loro precursori i seguaci della scuola di Megara, che avevano
acutamente individuato alcuni casi esemplari di antinomie insolubili. Nel II sec. a.C.
lo scetticismo fu l’atteggiamento dominante nell’ambito dell’Accademia platonica
(Terza o Nuova accademia), per lo più nella forma attenuata del probabilismo. Infine
fra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. lo scetticismo greco ritornò alle formulazioni radicali
di Pirrone, soprattutto per opera di Enesidemo, di Agrippa e di Sesto Empirico. Tra
gli intellettuali romani dei primi secoli dell’Impero lo scetticismo, per lo più in
forme attenuate e combinato ecletticamente con altre dottrine, fu largamente diffuso e
la sua vitalità era ancora forte ai tempi di sant’Agostino, che si sentì impegnato a
combatterlo e a confutarlo. Alle origini della filosofia moderna posizioni scettiche
più o meno conseguenti furono sostenute da Montaigne, da F. de La Mothe Le Vayer
(1588-1672) da F. Sanches. Il « dubbio metodico » venne introdotto da Cartesio
anche in risposta alle loro conclusioni, in fondo come una variante del classico
argomento contro lo scetticismo (l’assunzione del dubbio universale si capovolge in
certezze, come quella della realtà del dubbio, o dell’esistenza della mente che dubita
e simili). Montaigne aveva ritenuto per parte sua di potersi sottrarre alla forza
dell’argomento rifiutando ogni presa di posizione definitiva e rimanendo sospeso
nella invalicabile perplessità del « che so? ». La professione di scetticismo di uno
dei più grandi filosofi moderni, lo Hume, va considerata con molta cautela. Essa non
si conclude con l’abbandono e la rinuncia, ma implica positivamente l’avvertita
consapevolezza dei limiti della ragione umana, il senso della realtà, l’esigenza
scientifica della verifica costante, il riconoscimento della partecipazione all’attività
conoscitiva degli istinti, delle abitudini e delle passioni di cui è intessuta la « natura
umana ». La tesi che il criticismo di Kant fosse una variante « sofisticata » dello
scetticismo fu sostenuta in Italia tra gli altri dal Soave e dal Romagnosi, e con
particolare insistenza da Galluppi, Rosmini e Gioberti. Una tale interpretazione
trascura proprio i motivi più originali del pensiero di Kant e rientra nei limiti di una
prospettiva precritica, mentre le osservazioni molto puntuali dello Schulze, che nel
suo Enesidemo tentò di ricavare dall’esame delle contraddizioni della gnoseologia
kantiana la legittimazione di un suo più coerente scetticismo, prepararono la strada al
superamento idealistico del kantismo. Nella filosofia italiana del XX sec.
l’impossibilità della verità oggettiva e la riducibilità di tutte le asserzioni a labili
certezze soggettive sono state tesi variamente argomentate da G. Rensi, in polemica
contro il « trionfalismo » idealistico.
Bibliogr.: M. Dal Pra, Lo scetticismo greco, Milano 1950; R. H. Popkin, The