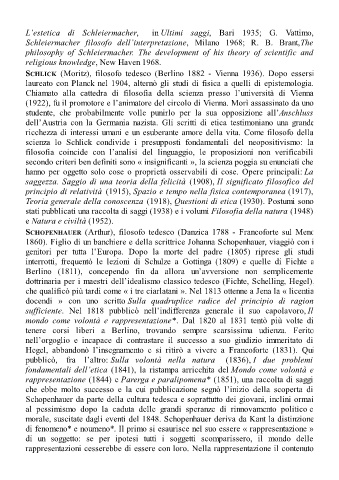Page 748 - Dizionario di Filosofia
P. 748
L’estetica di Schleiermacher, in Ultimi saggi, Bari 1935; G. Vattimo,
Schleiermacher filosofo dell’interpretazione, Milano 1968; R. B. Brant, The
philosophy of Schleiermacher. The development of his theory of scientific and
religious knowledge, New Haven 1968.
SCHLICK (Moritz), filosofo tedesco (Berlino 1882 - Vienna 1936). Dopo essersi
laureato con Planck nel 1904, alternò gli studi di fisica a quelli di epistemologia.
Chiamato alla cattedra di filosofia della scienza presso l’università di Vienna
(1922), fu il promotore e l’animatore del circolo di Vienna. Morì assassinato da uno
studente, che probabilmente volle punirlo per la sua opposizione all’Anschluss
dell’Austria con la Germania nazista. Gli scritti di etica testimoniano una grande
ricchezza di interessi umani e un esuberante amore della vita. Come filosofo della
scienza lo Schlick condivide i presupposti fondamentali del neopositivismo: la
filosofia coincide con l’analisi del linguaggio, le proposizioni non verificabili
secondo criteri ben definiti sono « insignificanti », la scienza poggia su enunciati che
hanno per oggetto solo cose o proprietà osservabili di cose. Opere principali: La
saggezza. Saggio di una teoria della felicità (1908), Il significato filosofico del
principio di relatività (1915), Spazio e tempo nella fisica contemporanea (1917),
Teoria generale della conoscenza (1918), Questioni di etica (1930). Postumi sono
stati pubblicati una raccolta di saggi (1938) e i volumi Filosofia della natura (1948)
e Natura e civiltà (1952).
SCHOPENHAUER (Arthur), filosofo tedesco (Danzica 1788 - Francoforte sul Meno
1860). Figlio di un banchiere e della scrittrice Johanna Schopenhauer, viaggiò con i
genitori per tutta l’Europa. Dopo la morte del padre (1805) riprese gli studi
interrotti, frequentò le lezioni di Schulze a Gottinga (1809) e quelle di Fichte a
Berlino (1811), concependo fin da allora un’avversione non semplicemente
dottrinaria per i maestri dell’idealismo classico tedesco (Fichte, Schelling, Hegel),
che qualificò più tardi come « i tre ciarlatani ». Nel 1813 ottenne a Jena la « licentia
docendi » con uno scritto Sulla quadruplice radice del principio di ragion
sufficiente. Nel 1818 pubblicò nell’indifferenza generale il suo capolavoro, Il
mondo come volontà e rappresentazione*. Dal 1820 al 1831 tentò più volte di
tenere corsi liberi a Berlino, trovando sempre scarsissima udienza. Ferito
nell’orgoglio e incapace di contrastare il successo a suo giudizio immeritato di
Hegel, abbandonò l’insegnamento e si ritirò a vivere a Francoforte (1831). Qui
pubblicò, fra l’altro: Sulla volontà nella natura (1836), I due problemi
fondamentali dell’etica (1841), la ristampa arricchita del Mondo come volontà e
rappresentazione (1844) e Parerga e paralipomena* (1851), una raccolta di saggi
che ebbe molto successo e la cui pubblicazione segnò l’inizio della scoperta di
Schopenhauer da parte della cultura tedesca e soprattutto dei giovani, inclini ormai
al pessimismo dopo la caduta delle grandi speranze di rinnovamento politico e
morale, suscitate dagli eventi del 1848. Schopenhauer deriva da Kant la distinzione
di fenomeno* e noumeno*. Il primo si esaurisce nel suo essere « rappresentazione »
di un soggetto: se per ipotesi tutti i soggetti scomparissero, il mondo delle
rappresentazioni cesserebbe di essere con loro. Nella rappresentazione il contenuto