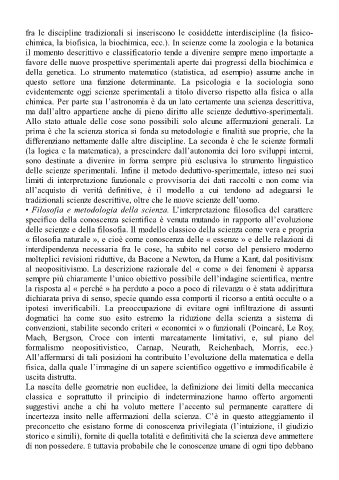Page 753 - Dizionario di Filosofia
P. 753
fra le discipline tradizionali si inseriscono le cosiddette interdiscipline (la fisico-
chimica, la biofisica, la biochimica, ecc.). In scienze come la zoologia e la botanica
il momento descrittivo e classificatorio tende a divenire sempre meno importante a
favore delle nuove prospettive sperimentali aperte dai progressi della biochimica e
della genetica. Lo strumento matematico (statistica, ad esempio) assume anche in
questo settore una funzione determinante. La psicologia e la sociologia sono
evidentemente oggi scienze sperimentali a titolo diverso rispetto alla fisica o alla
chimica. Per parte sua l’astronomia è da un lato certamente una scienza descrittiva,
ma dall’altro appartiene anche di pieno diritto alle scienze deduttivo-sperimentali.
Allo stato attuale delle cose sono possibili solo alcune affermazioni generali. La
prima è che la scienza storica si fonda su metodologie e finalità sue proprie, che la
differenziano nettamente dalle altre discipline. La seconda è che le scienze formali
(la logica e la matematica), a prescindere dall’autonomia dei loro sviluppi interni,
sono destinate a divenire in forma sempre più esclusiva lo strumento linguistico
delle scienze sperimentali. Infine il metodo deduttivo-sperimentale, inteso nei suoi
limiti di interpretazione funzionale e provvisoria dei dati raccolti e non come via
all’acquisto di verità definitive, è il modello a cui tendono ad adeguarsi le
tradizionali scienze descrittive, oltre che le nuove scienze dell’uomo.
• Filosofìa e metodologia della scienza. L’interpretazione filosofica del carattere
specifico della conoscenza scientifica è venuta mutando in rapporto all’evoluzione
delle scienze e della filosofia. Il modello classico della scienza come vera e propria
« filosofia naturale », e cioè come conoscenza delle « essenze » e delle relazioni di
interdipendenza necessaria fra le cose, ha subito nel corso del pensiero moderno
molteplici revisioni riduttive, da Bacone a Newton, da Hume a Kant, dal positivismo
al neopositivismo. La descrizione razionale del « come » dei fenomeni è apparsa
sempre più chiaramente l’unico obiettivo possibile dell’indagine scientifica, mentre
la risposta al « perché » ha perduto a poco a poco di rilevanza o è stata addirittura
dichiarata priva di senso, specie quando essa comporti il ricorso a entità occulte o a
ipotesi inverificabili. La preoccupazione di evitare ogni infiltrazione di assunti
dogmatici ha come suo esito estremo la riduzione della scienza a sistema di
convenzioni, stabilite secondo criteri « economici » o funzionali (Poincaré, Le Roy,
Mach, Bergson, Croce con intenti marcatamente limitativi, e, sul piano del
formalismo neopositivistico, Carnap, Neurath, Reichenbach, Morris, ecc.).
All’affermarsi di tali posizioni ha contribuito l’evoluzione della matematica e della
fisica, dalla quale l’immagine di un sapere scientifico oggettivo e immodificabile è
uscita distrutta.
La nascita delle geometrie non euclidee, la definizione dei limiti della meccanica
classica e soprattutto il principio di indeterminazione hanno offerto argomenti
suggestivi anche a chi ha voluto mettere l’accento sul permanente carattere di
incertezza insito nelle affermazioni della scienza. C’è in questo atteggiamento il
preconcetto che esistano forme di conoscenza privilegiata (l’intuizione, il giudizio
storico e simili), fornite di quella totalità e definitività che la scienza deve ammettere
di non possedere. È tuttavia probabile che le conoscenze umane di ogni tipo debbano