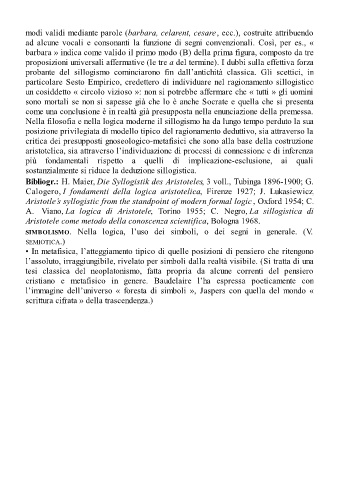Page 772 - Dizionario di Filosofia
P. 772
modi validi mediante parole (barbara, celarent, cesare, ecc.), costruite attribuendo
ad alcune vocali e consonanti la funzione di segni convenzionali. Così, per es., «
barbara » indica come valido il primo modo (B) della prima figura, composto da tre
proposizioni universali affermative (le tre a del termine). I dubbi sulla effettiva forza
probante del sillogismo cominciarono fin dall’antichità classica. Gli scettici, in
particolare Sesto Empirico, credettero di individuare nel ragionamento sillogistico
un cosiddetto « circolo vizioso »: non si potrebbe affermare che « tutti » gli uomini
sono mortali se non si sapesse già che lo è anche Socrate e quella che si presenta
come una conclusione è in realtà già presupposta nella enunciazione della premessa.
Nella filosofia e nella logica moderne il sillogismo ha da lungo tempo perduto la sua
posizione privilegiata di modello tipico del ragionamento deduttivo, sia attraverso la
critica dei presupposti gnoseologico-metafisici che sono alla base della costruzione
aristotelica, sia attraverso l’individuazione di processi di connessione e di inferenza
più fondamentali rispetto a quelli di implicazione-esclusione, ai quali
sostanzialmente si riduce la deduzione sillogistica.
Bibliogr.: H. Maier, Die Syllogistik des Aristoteles, 3 voll., Tubinga 1896-1900; G.
Calogero, I fondamenti della logica aristotelica, Firenze 1927; J. Lukasiewicz,
Aristotle’s syllogistic from the standpoint of modern formal logic , Oxford 1954; C.
A. Viano, La logica di Aristotele, Torino 1955; C. Negro, La sillogistica di
Aristotele come metodo della conoscenza scientifica, Bologna 1968.
SIMBOLISMO. Nella logica, l’uso dei simboli, o dei segni in generale. (V.
SEMIOTICA.)
• In metafisica, l’atteggiamento tipico di quelle posizioni di pensiero che ritengono
l’assoluto, irraggiungibile, rivelato per simboli dalla realtà visibile. (Si tratta di una
tesi classica del neoplatonismo, fatta propria da alcune correnti del pensiero
cristiano e metafisico in genere. Baudelaire l’ha espressa poeticamente con
l’immagine dell’universo « foresta di simboli », Jaspers con quella del mondo «
scrittura cifrata » della trascendenza.)