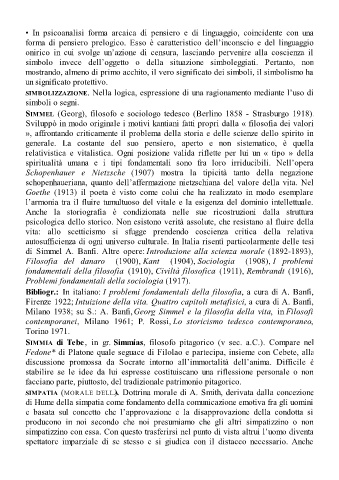Page 773 - Dizionario di Filosofia
P. 773
• In psicoanalisi forma arcaica di pensiero e di linguaggio, coincidente con una
forma di pensiero prelogico. Esso è caratteristico dell’inconscio e del linguaggio
onirico in cui svolge un’azione di censura, lasciando pervenire alla coscienza il
simbolo invece dell’oggetto o della situazione simboleggiati. Pertanto, non
mostrando, almeno di primo acchito, il vero significato dei simboli, il simbolismo ha
un significato protettivo.
SIMBOLIZZAZIONE. Nella logica, espressione di una ragionamento mediante l’uso di
simboli o segni.
SIMMEL (Georg), filosofo e sociologo tedesco (Berlino 1858 - Strasburgo 1918).
Sviluppò in modo originale i motivi kantiani fatti propri dalla « filosofia dei valori
», affrontando criticamente il problema della storia e delle scienze dello spirito in
generale. La costante del suo pensiero, aperto e non sistematico, è quella
relativistica e vitalistica. Ogni posizione valida riflette per lui un « tipo » della
spiritualità umana e i tipi fondamentali sono fra loro irriducibili. Nell’opera
Schopenhauer e Nietzsche (1907) mostra la tipicità tanto della negazione
schopenhaueriana, quanto dell’affermazione nietzschiana del valore della vita. Nel
Goethe (1913) il poeta è visto come colui che ha realizzato in modo esemplare
l’armonia tra il fluire tumultuoso del vitale e la esigenza del dominio intellettuale.
Anche la storiografia è condizionata nelle sue ricostruzioni dalla struttura
psicologica dello storico. Non esistono verità assolute, che resistano al fluire della
vita: allo scetticismo si sfugge prendendo coscienza critica della relativa
autosufficienza di ogni universo culturale. In Italia risentì particolarmente delle tesi
di Simmel A. Banfi. Altre opere: Introduzione alla scienza morale (1892-1893),
Filosofia del danaro (1900), Kant (1904), Sociologia (1908), I problemi
fondamentali della filosofia (1910), Civiltà filosofica (1911), Rembrandt (1916),
Problemi fondamentali della sociologia (1917).
Bibliogr.: In italiano: I problemi fondamentali della filosofia, a cura di A. Banfi,
Firenze 1922; Intuizione della vita. Quattro capitoli metafisici, a cura di A. Banfi,
Milano 1938; su S.: A. Banfi, Georg Simmel e la filosofia della vita, in Filosofi
contemporanei, Milano 1961; P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo,
Torino 1971.
SIMMIA di Tebe, in gr. Simmías, filosofo pitagorico (v sec. a.C.). Compare nel
Fedone* di Platone quale seguace di Filolao e partecipa, insieme con Cebete, alla
discussione promossa da Socrate intorno all’immortalità dell’anima. Difficile è
stabilire se le idee da lui espresse costituiscano una riflessione personale o non
facciano parte, piuttosto, del tradizionale patrimonio pitagorico.
SIMPATIA (MORALE DELLA). Dottrina morale di A. Smith, derivata dalla concezione
di Hume della simpatia come fondamento della comunicazione emotiva fra gli uomini
e basata sul concetto che l’approvazione e la disapprovazione della condotta si
producono in noi secondo che noi presumiamo che gli altri simpatizzino o non
simpatizzino con essa. Con questo trasferirsi nel punto di vista altrui l’uomo diventa
spettatore imparziale di se stesso e si giudica con il distacco necessario. Anche